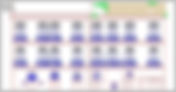LETTERATURA CAPRACOTTESE
GARE DI SCI A CAPRACOTTA
Istituto Nazionae Luce (1929)
"Gare di sci a Capracotta"
GARE DI SCI A CAPRACOTTA
Istituto Nazionae Luce (1929)
"Gare di sci a Capracotta"
IL RATTO DI BECKENBAUER
Flop TV (2009)
"La villa di lato"
di Maccio Capatonda (1978)
IL RATTO DI BECKENBAUER
Flop TV (2009)
"La villa di lato"
di Maccio Capatonda (1978)
IL RATTO DI BECKENBAUER
Flop TV (2009)
"La villa di lato"
di Maccio Capatonda (1978)
IL RATTO DI BECKENBAUER
Flop TV (2009)
"La villa di lato"
di Maccio Capatonda (1978)
VIRGILIO JUAN
CASTIGLIONE
Le arie popolari musicate da artisti capracottesi
NUNZIO
BACCARI
(1666-1738)
ALFONSO
FALCONI
ALFONSO
FALCONI
ALFONSO
FALCONI
NUNZIO
BACCARI
(1666-1738)
I risultati della tua ricerca
2291 risultati trovati con una ricerca vuota
- Amicizia
Cacchio! Oggi fa freddissimo. I vetri dei balconi sono appannati, con quell'alone tipico che rende i bordi sfumati e lascia giusto qualche goccia di condensa al centro che, scivolando lentamente, disegna righe e percorsi sulla lastra gelida e offuscata. Il tepore di casa si mescola al profumo del pranzo che arriva dalla cucina; le luci sono accese perché i raggi del sole non riescono ad illuminare, così tenui, la stanza; di sottofondo "November Rain" e, di tanto in tanto, la voce del cronista del tg che racconta gli avvenimenti recenti. L'atmosfera fa pregustare già il calduccio del Natale, caldo non tanto per i focolari accesi nelle case o per i termosifoni, ma caldo per le cose belle che si dicono, per quelle che si vivono, nonostante tutto e nonostante la tv, quando si sta insieme e ci si ritrova dentro, mentre fuori piove o, anche se non piove, il freddo schiaffeggia la carne. Servirebbe solo una bella spruzzata di neve per coprire tutto di bianco, come una gomma su foglio, e dire a tutti che un nuovo inizio è possibile! Che anche la natura ci invita a riscrivere la nostra vita cercando di dare il meglio, ogni volta! La rinascita della primavera non sarebbe possibile senza il freddo dell'inverno, senza la neve. Forse la vera primavera è proprio in inverno! Quando tutto è bianco e tutto si piò ancora scrivere! Che bella la neve! Soffice, carezzevole, ma comunque potente! Non cade veloce come la pioggia, o immediata come la grandine che fa male; no, la neve scivola lungo l'aria, si fa guardare, dice: «Eccomi, guarda, sto cadendo per coprire qualche macchia scura, pe dirti che puoi farlo anche tu!». E ne è convinta, lo sa. Per questo lo dice a tutti. Ci sono cose, infatti, che si sanno senza sapere il perché. È così e basta. Si sanno e si sente il bisogno di dirle! Come alcune parole che nascono mentre non te ne accordi e sbocciano improvvisamente dalla bocca, lasciando sbigottito anche te che le pronunci. Come un abbraccio che nasce timido ma deve nascere per forza, perché non puoi contenerlo. Come tutte le cose sincere: non te ne accorgi che ci sono fino a quando non impari a vederle. Ho dovuto interrompere per un po' la scrittura, ma, in fondo, è stata un'interruzione quasi provvidenziale. Sai che a Capracotta ha nevicato? Che è tutto bianco? Immagina un prato enorme, visto dall'alto, tutto immensamente e sofficemente bianco! Tutto da scrivere! Come la vita. Come l'amicizia. Come gli inizi: non sai mai con quali parole cominciare. Provi e poi cancelli. Riscrivi e ricancelli. E di nuovo, in un'altalena che ti gongola fino a quando non arrivano quelle bombe in mente che ti spostano da sola la mano sul foglio e tu non devi fare altro che reggere la penna. O premere i tasti del pc. Sto ricordando, scrivendo queste righe, la nostra amicizia, cercando anche di darti una definizione di cosa sia l'amicizia, di potertela raccontare, ma mi accorgo che più ci provo e più non ci riesco. Se potessi, ti allegherei i mille incipit che ho scritto e cancellato, fino al punto di cancellare l'intera sezione dell'amicizia. Ma poi... "perché"? Solo perché non so definire un sentimento, non vuol dire che non possa parlarne, perché i sentimenti, in fondo, non vanno definiti, ma vissuti. Allora ho deciso di ricordare alcuni momenti veri e belli della nostra amicizia, trascorsi insieme anche ad altri amici, sfumandoli un po', ma sapendo che sono sempre vividi e nitidi nella memoria, nel cuore. Il primo ricordo che mi viene in mente è legato ad una foto, a dei colori poco saturi ma a parole vere: – Per me è tutto. Non so dire il perché, ma questa volta davvero ci sto bene. E via a passeggiare tra pineta e battigia spoglia, col vento che smuoveva il mare invernale. Quanto propositi avevi? Quanti sogni hai inciso con le impronte sulla sabbia bagnata? Quanti se n'è presi il mare con la delicatezza della spuma e il cinismo di chi non cambia mai il il suo corso? E poi l'immondizia, il reportage quel che resta dell'estate e le risate quando mi hai detto: «Non sono mai stato in montagna!». A me? A uno che in montagna ci starebbe da un anno all'altro? Mare o montagna che sia, su un punto eravamo d'accordo senza averne parlato: davanti all'immensità della natura ogni cosa diventa più bella, più serena. Come parlare a lungo di notte, fino al mattino presto o fermarsi al mare a guardare il cielo pieno di stelle col sottofondo della risacca e delle musiche dei cellulari degli altri amici. E i lunghissimi silenzi "fuori sede" e i va a quel paese sinceri ma mai offensivi. Ricordi anche il convento di S. Matteo? Quel freschetto che in poco tempo ha reso tutta l'aria frizzante e il baccano, col tirmore che i frati uscissero da un momento all'altro. Loro non aprirono alcuna finestra, ma una pattuglia di black security fece un giro intorno alla panchina dove stavamo mangiando. Cose usuali, comuni come dire "buongiorno" ogni mattina a chi ci sta accanto, ma belle perché vere, essenziali, libere. Cose che tutti possono vedere ma che solo chi vive può ricordare. Cose che si aggiungono ad altre cose e scavano, creano, raccontano. Cose che si aggiungono ad altre cose, ad altre cose non dette, perché ci sono cose che vivono in noi e di uscire, proprio non ne vogliono sapere. Cose che si trasformano in immagini. In profumi. In suoni. Cose che diventano ricordi. Ricordi che fanno appoggiare la storia. Cose che già vedono il futuro. Amedeo Di Tella Fonte: A. Di Tella, Lettera ad un amico lontano, Lucera 2014.
- Jersey City spazza la neve di Capracotta (II)
Fino a questo punto arriva la versione ufficiale. Però, dalle lettere dei parenti residenti a Jersey City, la storia appare leggermente diversa. È vero che il vecchio spazzaneve fu distrutto dai tedeschi in fuga nella valle del Sangro, è vero che il sindaco Carnevale scrisse al Mayor di Jersey City, ma l'idea del "Capracotta-Clipper" è nata in America, dalla mente stessa del sindaco John V. Kenny. Alcuni capracottesi residenti a Jersey City, tra i quali Francesco Angelaccio e Vincenzo Sozio, in lettere al cugino Felice Santilli, sarto di Capracotta, danno allo «affare dello spartineve» un'origine puramente politica: nel mese di gennaio prossimo, nello stato del New Jersey si svolgeranno le elezioni e i voti dei 35 mila italiani hanno la loro importanza. L'idea dello spazzaneve a Capracotta sembra sia stata concertata tra il Mayor e il deputato italo-americano Louis P. Messano: appena venuti a conoscenza del progetto, alcuni oriundi capracottesi avvertirono d'urgenza i loro parenti, questi corsero dal sindaco Carnevale che spedì la famosa lettera. La versione è resa più valida dal seguente particolare: lo spazzaneve fu comprato dal comune di Jersey City prima di iniziare la sottoscrizione, e ciò dimostra che se invece di 20 mila dollari - prezzo pagato per l'apparecchio - se ne fossero raccolti di meno, lo spazzaneve sarebbe stato inviato ugualmente al comune di Capracotta. Don Gennarino va e viene da Roma e conta i giorni che mancano al 1° dicembre. L'altro giorno, gli è giunta una lettera del signor Giovanni Arbitello, abitante di Trenton, poco distante da Jersey City, nella quale gli si raccomandano quattro punti fondamentali: i ringraziamenti al sindaco di Jersey City, appena il "Capracotta-Clipper" avrà toccato la strada da Monte Forte a Monte Capraro, una pergamena del comune con le firme dei consiglieri e del sindaco, una strada del paese intitolata al nome di John V. Kenny e un premio alla donna che metterà per prima un figlio al mondo al quale vengano imposti i nomi di John e Vincent. Gennaro Carnevale è già al lavoro e la leggenda del premio ha già messo in allarme le future madri di Capracotta. La pergamena, dice il vice-sindaco Pettinicchio, costerà trentamila lire ma si farà uno storno di bilancio. Per la strada, è opinione che al Mayor del "Capracotta-Clipper" verrà intitolata la via d'accesso al villaggio. Il 16 dicembre la Capracotta ufficiale sarà tutta a Napoli. I pastori, i borghesi, i cacciatori, i carbonai, le donne si rovescieranno in piazza per salutare Gennaro Carnevale seduto al volante del "Capracotta-Clipper" con la fascia tricolore di sindaco. I maligni sussurrano che lo spartineve consumerà troppa nafta e che alla fine bisognerà venderlo a un comune più ricco per contentarsi di uno meno costoso. Ma questo è un discorso «d'opposizione» del quale non bisogna tener conto, almeno per ora. Gennaro Carnevale ha legato il suo nome all'impresa e il suo immediato programma conta già il piano di lotta contro i lupi che infestano le montagne vicine e che l'anno scorso sbranarono un soldato, certo Del Castello, mentre due settimane fa hanno assaltato una stalla alle porte del paese. Così si chiude la storia del "Clipper": Capracotta avrà lo spazzaneve e il Mayor Kenny i voti elettorali degli italiani del New Jersey. Ilario Fiore Fonte: I. Fiore, Jersey City, NJ, spazza la neve di Capracotta, in «La Settimana Incom», II:46, Roma, 12 novembre 1949.
- Jersey City spazza la neve di Capracotta (I)
Capracotta, novembre. Nel cuore dell'Appennino molisano, a ottanta chilometri da Sulmona e a quarantacinque da Ortona a Mare, i quattromila abitanti di Capracotta stanno vivendo febbrili giornate di attesa. La neve è scesa l'altra notte da Monte Capraro, altra ne verrà presto e per Natale, sulla strada che da Monte Forte conduce al paese, si ammucchieranno dai tre ai quattro metri di neve: così Capracotta sarà isolata dal resto del mondo e fino a maggio nessuno potrà scendere a Castel di Sangro o a Staffoli. Dalla fine della guerra ad oggi, la neve è stata un incubo per il sindaco e la popolazione: per fortuna, adesso, il rimedio è quasi pronto e se Dio vuole, per l'inverno già cominciato, il comune disporrà del più moderno spazzaneve d'Europa e Capracotta non sarà più sepolto e isolato sei mesi all'anno. L'iniziativa di fornire uno spazzaneve al paese è partita da una città americana, Jersey City, una propaggine di New York, ma l'affare si sta complicando e nessuno degli abitanti del paese è oggi in grado di dare una versione sicura di tutta la faccenda. Il sindaco di Capracotta, Gennaro Carnevale, uomo abile nell'amministrare le cose locali, vive tra il paese abruzzese e Roma, proprietario di due farmacie, una in montagna e l'altra in città. Nel mese di luglio, seriamente intenzionato di liquidare la voce comunale dello spazzaneve, don Gennarino scrisse una lettera al sindaco di Jersey City, John V. Kenny, illustrandogli drammaticamente la situazione di Capracotta e pregandolo di interessarsi affinché, prima dell'inverno, ottenesse dall'obolo dei suoi cittadini la somma per acquistare uno spartineve. Perché il sindaco italiano abbia scritto al sindaco della città del New Jersey e non al sindaco di un'altra città americana, si spiega tenendo conto che nello stato del New Jersey vivono 35 mila emigranti italiani, di cui quattromila abruzzesi e quasi 500 ex-cittadini di Capracotta. Gennaro Carnevale sapeva di colpire nel segno: la sua lettera, infatti, ebbe un successo immediato, il sindaco Kenny adunò i suoi collaboratori, tra cui il giudice Edward Zampella, oriundo abruzzese, preparò il piano della sottoscrizione e nel mese di agosto, dalla casa del Mayor di Jersey City, partì la lettera per Gennaro Carnevale che diceva: «Avrete lo spartineve, i miei concittadini hanno risposto all'appello e per Natale potete stare tranquilli!». Da allora, notizie sono giunte sempre più numerose, dai giornali e dalle lettere dei capracottesi del New Jersey che scrivono ai parenti d'Abruzzo. Lo spazzaneve, battezzato "Capracotta-Clipper", fu acquistato a Boston coi fondi del comune: pesante 12 tonnellate, è del tipo usato in Alaska, col vomero alto e snodato, manovrabile dall'interno della cabina del motore. Non ha la turbina, quindi non si può chiamare spazzaneve, tecnicamente è soltanto uno "spartineve". Esposto in una piazza di Jersey City, fu visitato da migliaia di connazionali che osannarono naturalmente al sindaco Kenny e lodarono il suo amoroso interessamento per il povero e sperduto villaggio italiano. La sottoscrizione raccolse ventimila dollari, circa 12 milioni, quanti ne sono necessari per pagare il prezioso congegno meccanico. Domenica 23 ottobre, il "Capracotta-Clipper" fu issato su un camion e, durante una solenne parata per le strade, venne portato dal quartiere italiano fino a Journal Square. Bambini figli di emigrati, indossanti costumi abruzzesi, portarono fiori al Mayor Kenny, il giudice Zampella pronunciò un vibrante discorso, il reverendo Gerardo Santoro benedisse l'apparecchio mentre i capracottesi piovuti con pullman e macchine anche da Trenton, Filadelfia, Florence, Princeton e Bristol, avevano gli occhi bagnati di lagrime. Poi, una società di trasporti si offerse di caricare gratis il "Capracotta-Clipper" da Boston a Napoli su un piroscafo mercantile che arriverà il 16 dicembre. Ilario Fiore Fonte: I. Fiore, Jersey City, NJ, spazza la neve di Capracotta, in «La Settimana Incom», II:46, Roma, 12 novembre 1949.
- I commandos polacchi a Capracotta e Pescopennataro
Il 1° dicembre 1943, nel porto di Taranto, approdò la nave "Ville d'Oran" che trasportava, destinata alla missione in Italia, la 1ª Compagnia Indipendente Commando guidata dal capitano Władysław Smrokowski. L'unità di commando polacca fu formata ed addestrata per oltre un anno nei territori della Scozia, del Galles e dell'Inghilterra. Faceva parte del 10° Inter-Allied Commando, come sua sesta compagnia. Esattamente a 75 anni dallo svolgersi di quegli eventi, vogliamo ricordare il contributo di questa piccola unità militare, che fu la prima a combattere sotto lo stemma dell'aquila bianca una vittoriosa battaglia sul suolo italiano, ancora prima della gloriosa vittoria del 2° Corpo d'Armata polacco nella battaglia di Monte Cassino. Inizialmente, le compagnie commando - polacca e belga - e il plotone jugoslavo furono trasportate per ferrovia da Taranto alla cittadina di Molfetta. Qui il 3 dicembre, nel cortile della locale scuola cittadina, il brigadiere Tom Churchill, comandante della No. 2 Special Service Brigade, informò gli arrivati che le due unità di commando erano state inserite nel suo gruppo. I soldati furono informati che il compito a loro assegnato riguardava le operazioni di pattugliamento e di esplorazione nell'area montuosa del fronte, sull'ala sinistra delle unità dell'8ª Armata britannica. Ci fu anche l'ordine di assegnare a entrambe le compagnie commando due soldati dal plotone jugoslavo come traduttori. La compagnia dei commando polacchi contava 91 soldati e fu inizialmente inserita nella famosa per le battaglie in Africa 78ª Divisione di fanteria "Battleaxe" e posta sotto gli ordini diretti del 56° Reggimento di ricognizione. Il 12 dicembre la compagnia commando del capitano Smrokowski iniziò il suo spostamento verso il fronte. Viaggiando su camionette, in un itinerario che toccò le città di Barletta, Foggia e Lucera, i commandos giunsero a Bojano, un piccolo paese della provincia di Campobasso dove pernottò. Il pomeriggio del giorno seguente la compagnia raggiunse il paese di Capracotta, ubicato a 1.421 metri sul livello del mare. Qui sono stati distribuiti i singoli plotoni e il comandante della compagnia ordinò di effettuare durante la notte il primo servizio di ronda e di pattugliamento nei pressi del fiume Sangro, in prossimità della città di Castel del Giudice. La mattina del 14 dicembre, il secondo plotone di commando polacco intraprese la marcia da Capracotta alla vicina località di Pescopennataro (1.237 m sul livello del mare) con il compito di sostituire i soldati britannici del reggimento di ricognizione, lì presenti da qualche giorno. Diamo la parola al comandante del plotone del comando polacco Maciej Zajączkowski: La mattina il secondo plotone guidato dal capitano Wołoszowski e tenente Zalewski si mise in marcia verso Pescopennataro. Era un piccolo villaggio nascosto tra ripide rocce, distante circa 6 chilometri in linea retta da Capracotta. C'era una strada che portava là, ma i commandos non potevano utilizzarla. [...] Il paesino era quasi completamente distrutto. I tedeschi in ritirata avevano fatto esplodere quasi tutte le case. Soltanto una delle due chiese e la casa del sindaco si erano salvate. Nel frattempo, la sera del 14 dicembre, un'altra pattuglia dei commandos polacchi partì da Capracotta per esplorare l'area di Ateleta e gli edifici posti sulle colline sulla sponda opposta del fiume Sangro. Il giorno seguente, durante l'attacco a una delle case della Masseria Rossi sulla collina 829, morì Franciszek Rogucki, un volontario dell'americano Pittsburgh. Fu il primo soldato polacco caduto in Italia nella campagna del 1943-45. Fu sepolto inizialmente al cimitero di Capracotta (nel 1945 i resti di Franciszek Rogucki furono trasferiti al Cimitero Militare Polacco a Loreto). Parallelamente alle azioni condotte dai plotoni presenti nell'area di Capracotta, altre operazioni di ricognizione furono svolte dal secondo plotone di commando di stanza a Pescopennataro. Qui i commandos polacchi diedero avvio alle attività di pattugliamento nelle aree circostanti le cittadine di Borrello e Quadri situate nelle vicinanze del fiume Sangro. Il 18 dicembre il plotone di comando e il primo plotone partirono dal loro precedente luogo di stazionamento per raggiungere Pescopennataro, poiché alla compagnia polacca fu assegnato il compito di pattugliare ed esplorare un lungo tratto del fronte, sul fiume Sangro, compreso tra S. Angelo del Pesco e Villa S. Maria. A Capracotta sono rimasti soltanto gli autisti e i soldati che si occupavano dell'approvvigionamento. A Pescopennataro, al comando di compagnia dei commandos polacchi fu assegnato l'edificio del sindaco, rimasto in piedi dopo la ritirata dei tedeschi. Sulla porta dell'edifico i tedeschi lasciarono un biglietto con su scritto: "Lasciamo questa casa ai vostri feriti". L'area più vicina all'edificio fu occupata dal plotone di comando. Il primo plotone si acquartierò tra le mura della Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, parzialmente distrutta dai tedeschi, situata sul lato settentrionale del paese, mentre i soldati del secondo plotone installarono le loro postazioni tra le rovine delle case diroccate presenti nella parte meridionale dell'abitato. Il paesaggio di Pescopennataro era quello della totale distruzione. Quasi tutti gli edifici vennero rasi al suolo dai tedeschi. La popolazione locale fu costretta a condividere il suo destino con i soldati polacchi cercando un po' di riparo nelle cantine e tra le rovine del paese poiché non aveva un posto dove andare. La scarsità del cibo e le basse temperature, tipiche su questo territorio, resero la loro situazione di vita ancora più tragica. Una settimana prima del Natale, nel pomeriggio del 18 dicembre, la pattuglia di ricognizione guidata dal capitano Stanisław Wołoszowski, il vice comandante della compagnia dei commandos polacchi, partì in direzione di Borrello e Villa S. Maria. A Villa S. Maria il comandante Wołoszowski, grazie alle indicazioni fornite dal sindaco locale, arrestò con galanteria, parlando in francese, una parente di Mussolini, la signora Farinacci, che fu poi consegnata al comando britannico. Nei giorni successivi i commandos furono impegnati a pattugliare le aree nei pressi di S. Angelo del Pesco, Quadri e Borrello. Il 21 dicembre, la posizione dei commandos polacchi a Pescopennataro fu visitata dal brigadiere Churchill che si complimentò con il capitano Smrokowski per le eccellenti azioni di pattuglia svolte dai suoi soldati. La stessa sera, verso le ore 18:00, il capitano Smrokowski fu urgentemente informato dalla presenza di truppe tedesche in marcia verso i villaggi di Pescopennataro e Capracotta. L'unità tedesca composta da circa 250 soldati era partita da Gamberale con l'obiettivo di conquistare entrambi i villaggi. Fu emesso l'ordine di organizzare immediatamente la difesa e mantenere a ogni costo Pescopennataro e postazioni di artiglieria britannica a Capracotta. Il comandante Smrokowski diede l'ordine di stabilire una linea di difesa, sebbene questa non fosse una delle migliori mosse tattiche nelle operazioni di truppe speciali e nel loro destino. Durante il briefing con i comandanti dei plotoni, il capitano Smrokowski ordinò al primo plotone di preparare un'azione difensiva nella parte centrale del paese chiudendo l'uscita per Agnone e la strada a nord. Al secondo plotone fu affidato il compito di difendere l'unica strada che conduceva fuori città verso la valle del Sangro in direzione di S. Angelo del Pesco e di mantenere l'area degli edifici nei pressi del cimitero. Infine il plotone di comando chiudeva l'area orientale degli edifici e aveva a disposizione la squadra dei mortai. Mezz'ora dopo aver emesso ordini, i commandos polacchi erano pronti alla difesa sulle posizioni assegnate. Nel frattempo, la popolazione locale è stata condotta in rifugio tra le mura della chiesa superstite (Chiesa della Madonna delle Grazie), sita nella piazza centrale della città. Intorno alle ore 20:30 i soldati tedeschi delle truppe alpine, confluendo da più direzioni, sferrarono il loro attacco su Pescopennataro tentando di rompere la difesa ma furono respinti da un deciso fuoco difensivo. L'azione di difesa più difficile fu sostenuta dai soldati del secondo plotone dei commando poiché si trovarono a dover respingere l'attacco tedesco che fu condotto dalla sovrastante collina vicino al cimitero. I cruenti combattimenti si svolsero a distanza ravvicinata con l'utilizzo di armi da fuoco leggere, bombe a mano e sotto la pioggia di fuoco dei mortai. Dopo circa un'ora i tedeschi lanciarono un secondo attacco che fu respinto al termine di un duro scontro che durò fino a mezzanotte. In prossimità del paese di Capracotta operavano attivamente le batterie dell'artiglieria britannica. La conquista di queste postazioni rappresentava il secondo obiettivo del piano di attacco tedesco, dopo la presa di Pescopennataro. Dai margini del paese arrivavano in maniera incessante i boati delle esplosioni dei combattimenti che provocarono un forte spavento tra i civili che si erano rifugiati all'interno della piccola Chiesa della Madonna delle Grazie. Durante l'incessante battaglia, dall'interno della chiesa si udivano provenire le grida isteriche delle donne, il pianto dei bambini, i canti di preghiera. Il fuoco dell'artiglieria cessò verso l'una di notte ed i soldati delle truppe alpine tedesche ne approfittarono per tentare altri attacchi, molto meno decisivi. L'ultimo impetuoso tentativo di assalto fu condotto dai tedeschi verso le tre del mattino. L'attacco fu fermamente e sanguinosamente respinto. All'alba il capitano Smrokowski fece uscire le pattuglie esplorative che confermarono il ritiro dei tedeschi. Fu così che a Pescopennataro un'incompleta compagnia di commandos polacchi, composta da soli 80 soldati, era riuscita a sconfiggere un avversario tre volte più forte, l'eccellente unità tedesca dei famosi Gebirgsjäger. Dopo quei scontri il comando britannico ha emesso l'ordine di rinforzare la linea di difesa su quella parte del fronte. A Capracotta fu inviato un squadrone di riserva, mentre a Pescopennataro è stata indirizzata la compagnia irlandese dal reggimento di Inniskilling Fusiliers e due plotoni di genieri. A questi fu affidato il compito di minare tutti i sentieri e le strade site nella prossimità della città, mentre i commandos polacchi dovevano tornare a pattugliare i terreni sul Sangro. Gli irlandesi ai quali fu affidato il compito di proteggere la città furono alloggiati nella parte settentrionale di Pescopennataro, là dove precedentemente stazionava il primo plotone del commando polacco. Il 23 dicembre la 1ª Compagnia Commando Indipendente polacca ricevette dal comandante della 78ª Divisione di fanteria, generale C. Keightley, una lettera di congratulazioni per l'eroica difesa di Pescopennataro. Lo stesso giorno i commando polacchi ricevettero la visita del colonnello Klemens Rudnicki che stava lavorando alla realizzazione di un report per il 2° Corpo d'Armata polacco che stava in arrivo sul fronte italiano. I giorni seguenti i commando polacchi passarano a pattugliare l'area di Borrello e S. Angelo del Pesco. Il 25 dicembre, giorno di Natale, incominciò a nevicare. Tutto fu coperto da una fitta coltre bianca. Le bufere di neve continuarono senza tregue anche nei giorni successivi. La sera del 29 dicembre una pattuglia, tornando da Villa S. Maria a Pescopennataro, si addentrò in un sentiero precedentemente minato dagli irlandesi. Il soldato Stanisław Stadnik, uno dei pochi alpinisti presenti nella compagnia polacca, incappò su una mina che lo ferì gravemente causandone la morte. Il giorno dopo fu sepolto nel piccolo cimitero di Pescopennataro (nel 1945 i resti di Stanisław Stadnik furono trasferiti al Cimitero Militare Polacco di Montecassino). Le azioni condotte dai commandos polacchi nel periodo compreso tra il 13 e il 29 dicembre del 1943 permisero di conoscere le forze nemiche, difendere delle importanti posizioni sul fronte ma anche di documentare il comportamento criminale dei soldati tedeschi su questo tratto della Linea Gustav. Il 17 dicembre a Quadri, la pattuglia del tenente Stefan Zalewski che operava dal lato opposto del fiume Sangro, vide l'assassinio di una ragazza italiana. La giovane fu fucilata. Il 20 dicembre, nella cappella del cimitero di S. Angelo del Pesco furono scoperti i cadaveri di tre uomini fucilati la notte precedente. Inoltre gli abitanti di alcune cittadine sul Sangro informarono i soldati polacchi di diversi atti di prepotenza da parte dei tedeschi. Denunciarono frequenti saccheggi di cibo, bestiame e altri beni. In reazione al comportamento criminale dei tedeschi, gli italiani fornirono ai soldati polacchi preziose informazioni sui movimenti delle loro truppe e la dislocazione delle postazioni militari. I dati raccolti consentirono ai commandos di riportare sulle mappe le posizioni nemiche e di segnalarle al comando britannico. Il 29 dicembre, a Villa S. Maria i polacchi trovarono un gruppo di minatori dell'Alto Adige deportati dai tedeschi ed impegnati, in regime di lavoro forzato, alla realizzazione di alcune opere minatorie. Sul finire del 1943 le forti nevicate tagliarono fuori dai rifornimenti i polacchi e gli irlandesi di stanza a Pescopennataro. Per cercare di risolvere la situazione fu impartito l'ordine dello scavo di un tunnel, attraverso la neve, in direzione di Capracotta, ma il lavoro non poté essere svolto a causa delle incessanti nevicate. Per far fronte al problema, dal 7 gennaio 1944 furono effettuati su Pescopennataro dei lanci paracadutati di contenitori contenenti viveri e armi. Il 10 gennaio i soldati polacchi riuscirono a farsi strada tra un imponente cumulo di neve scavando un tunnel in direzione di Capracotta. Nello stesso giorno il capitano Smrokowski ricevette l'ordine di spostare la sua compagnia da Pescopennataro ad Agnone. Si concluse così il primo capitolo del valoroso servizio svolto dei commandos polacchi nella Penisola appenninica. I due compagni caduti furono lasciati a Capracotta e Pescopennataro mentre alcuni feriti furono inviati in ospedali da campo nelle retrovie. La compagnia commando, in numero incompleto dopo le azioni svolte sul fiume Sangro, fu inviata sulla costa occidentale dell'Italia dove, appena una settimana dopo, partecipò alla prima battaglia di Monte Cassino attraversando il fiume Garigliano e combattendo nell'area del paese di Suio e Castelforte. Krzysztof Piotrowski (trad. di Danuta Wojtaszczyk) Fonte: https://naszswiat.it/, 5 marzo 2019.
- Un apoftegma per Nunzio Baccari
Nunzio Baccari nacque a Capracotta il 22 giugno 1666 da Filippo e Cesarea Baccari. Nel rione S. Antonio la sua famiglia possedeva «una casa con un'altra casetta contigua con mobili, et utensilij, e coll'hosto avanti per uso proprio fra soprani, e sottani l'una, e l'altra membri 32», oltre a «territorij tomola 131, cioè tomola 84 colti, e 39 incolti, e pratini tomola 8 assegnati per patrimonio sacro [...] nella pertinenza d'Agnone». Le rendite familiari provenivano dalle locazioni presso la Regia Dogana della mena delle pecore di Foggia, consistenti in «una massaria di pecore con cavalli, somari, e bovi, giumente indomite, e vacche, delle quali vacche la maggior parte le tiene in società, che sono della veneranda Cappella di S. Maria di Loreto di questa Terra». Insomma, la famiglia Baccari era sicuramente una delle più agiate di Capracotta e difatti Nunzio fu avviato alla vita religiosa d'alto rango. Mi piace credere che Cesarea lo partorì sotto un persistente aroma di ginepro e che lo chiamò Nunzio con la speranza che diventasse messaggero di Dio... e tale fu, nomen omen. Formatosi probabilmente nel nostro ginnasio e trasferitosi in giovane età a Prezza (AQ), fu ordinato sacerdote il 15 aprile 1693 per venir nominato vescovo di Bojano il 14 marzo 1718 sotto papa Clemente XI. In seguito, grazie alla benevolenza del cardinal Vincenzo Maria Orsini - futuro papa Benedetto XIII - che lo aveva voluto al suo fianco a Benevento, Nunzio fu nominato vicegerente di Roma, colui che «coadiuva il vicario generale per la diocesi di Roma nelle sue funzioni di governo», una carica di grandissima responsabilità e di altissimo onore. La più importante opera di Nunzio Baccari fu quella realizzata presso il Conservatorio di S. Pasquale Baylon, situato a Roma in via Anicia, un'istituzione di particolare valore nell'ambito delle iniziative in favore degli orfani. Difatti, nel 1724 Nunzio «raccolse otto fanciulle che vagavano per la città senza educazione e le affidò a una pia signora genovese, Caterina de Rossi, assegnando due baiocchi e mezzo al giorno per ognuna di esse, a difesa della loro onestà ed innocenza». Potrei dire che il Vescovo strappò alla strada ragazze che facilmente si sarebbero traviate, rischiando di finir violentate o ammazzate nei pericolosi vicoli della Roma tardobarocca. Nunzio Baccari morì a Roma il 3 gennaio 1738 sotto il pontificato di Clemente XII. Mi sento particolarmente legato alla figura di Nunzio perché spero che diventerà il protagonista del mio primo romanzo, intitolato appunto "Nuntio, vobis". L'idea del romanzo nacque quando, alcuni anni fa, scoprii il luogo di sepoltura del Vescovo ma, con l'intento di ricostruire all'indietro la sua vita, non riuscii a recarmi sulla sua tomba, posta all'interno della Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, in terza posizione rispetto alla «linea di mezzo prossima alla cantoria», perché il rettore dell'istituto era appena deceduto e contemporaneamente erano in corso dei lavori di restauro. Oggi voglio però regalarVi un'anteprima della mia ricerca, un mistero che avvolge la vita di Nunzio Baccari e che, ai miei occhi, lo rende tanto affascinante. Mi riferisco alla missiva che padre Angelo Cancellieri, abate del monastero benedettino di Matelica (MC), inviò il 19 ottobre 1734 al re Carlo III di Borbone, incentrata proprio sul nostro prelato. Quella lettera conteneva infatti un apoftegma (l'espressione di una sentenza profetica) secondo il quale Nunzio sarebbe diventato papa dopo Clemente XII. In realtà il Baccari morirà proprio sotto il pontificato di Lorenzo Corsini, eletto il 12 luglio 1730, e non potrà beneficiare in alcun modo di quella rivelazione. Tuttavia, questo suggestivo presagio non deve meravigliare più di tanto. Con l'avvicinarsi di un conclave erano tanti i religiosi sparsi in ogni parte d'Europa che si premuravano di prevedere l'elezione pontificia - ora di questo ora di quello - sperando di influenzare in qualche modo i cardinali elettori. Questa abitudine era talmente malvista dai cronisti più ortodossi da aver dato vita al seguente detto: Chi in Conclave entra con indizio di poter riuscire Papa, ne esce sempre Cardinale. L'autore della profezia, Angelo Cancellieri, monaco benedettino, era nato a Matelica nel 1689 ed aveva indossato l'abito monastico nella congregazione «de' PP. Silvestrini, e fatta la carriera degli studj, e de' gradi regolari, conseguì meritamente quello di Abate, avendo di più avuto l'onore di esser benedetto in Roma dal sommo Pontefice». Ad una prima analisi, penso che padre Cancellieri avesse voluto blandire Carlo III, incoronato il 15 maggio 1734 re di Napoli, con la possibilità di un imminente papa abruzzese, meridionale, quindi lontano dagli intrighi politici di Roma e più facilmente plasmabile dai Borbone. La misteriosa epistola è la seguente: Sacra Real Maestà. È tanta la gioja che sento nelle gloriose conquiste delle vittoriose armi della Maestà Vostra, per la sorte che ho d'essere suo suddito di origine, venendo li miei antenati come è ben noto dalla città di Pistoja. Che se lo stato mio di Religioso Silvestrino dell'Ordine di S. Benedetto, ed il grado che sostengo di Abate e Superiore di questo Monistero non mel vietassero cercherei certamente poter applicare le mie qualunque sieno deboli forze in servizio della Maestà Vostra. Ma giacché non m'è permesso spargere il sangue per la sua corona si degni per lo meno la M. V. benignamente permettermi, che v'impieghi l'inchiostro. Ben vede, invitto Monarca, quanto potria esserle giovevole un Pontefice Nazionale di Napoli e interessato come il presente per la sua reale persona. Essendomi non pertanto riuscito più volte spiegarle anche preventivamente come senz'altri testimoni sonovi costì veraci li congiunti del fu Duca di Gravina, cui, defonto Innocenzo XIII, annunziai l'esaltazione di Benedetto XIII, prego la di lei gentilezza a compiacersi, che io le significhi col qui accluso umilissimo foglio questi amminicoli, che in tutto e in parte dovranno verificarsi nel futuro Conclave, e che si adattano appieno ad un soggetto che per anco non è Cardinale, ma in grado; voglio dire Monsignor Vescovo di Bojano Nunzio Baccari suddito della Maestà Vostra e Vice Gerente di Roma. Sicuro che qualor non riesca trovare altri cui si convenga una simigliante spiegazione, egli dovrìa essere lo prescelto da Dio alla Reggenza della Santa Chiesa. E pregando la Maestà Vostra a compiacersi non isdegnare il reverendissimo ufficio in olocausto di vero ossequio per potermi lusingare vivere nel numero de' suoi più infimi vassalli rispettosissimi e fedelissimi servi, mi umilio a piè del suo regal soglio. Matelica nella Marca Anconitana li 19 ottobre 1734. Umilissimo Devotissimo Padre Cancellieri Monaco Silvestrino. Il foglio accluso alla lettera, nel quale padre Cancellieri dimostrava come i tre precedenti papi fossero stati eletti sulla scorta delle profezie dell'abate Gioacchino da Fiore, Ve lo risparmio per rispetto della religione. Credo che sia fondamentale tenere a mente un dato: sembra che questi oracoli fuori tempo massimo non nutrissero alcuna fiducia nello Spirito Santo, la cui azione, stando alla teologia cattolica, è invece imprescindibile durante il rito del conclave. Al di sopra di queste macchinose manovre politiche stava Nunzio, messaggero del Signore, uomo del bene, cristiano vero e... papa apoftegmatizzato! Francesco Mendozzi Bibliografia di riferimento: G. F. Cecconi, Roma sacra, e moderna, Mainardi, Roma 1725; «Il Corriere Ordinario», Vienna, 19 novembre 1721; P. de Stephanis, Prezza, in F. Cirelli, Il Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato, Nobile, Napoli 1856; «Diario ordinario», 1798, Roma, 12 febbraio 1729; «Diario ordinario», 2011, Roma, 24 giugno 1730; «Diario ordinario», 2059, Roma, 14 ottobre 1730; L. Lancellotti, La Regia chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani in Roma, Guerrera, Napoli 1868; G. Masciotta, Il Molise dalle origini ai nostri giorni, vol. I, Pierro, Napoli 1914; F. Mendozzi, Guida alla letteratura capracottese, vol. I, Youcanprint, Tricase 2016; V. Monachino, La carità cristiana in Roma, Cappelli, Bologna 1968; G. Moroni Romano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni, vol. XCIX, Tip. Emiliana, Venezia 1860; N. Mosca, Libro delle memorie, o dei ricordi, Capracotta 1742-1947; C. Orlandi, Delle città d'Italia e sue isole adiacenti, libro V, Riginaldi, Perugia 1778; G. Rossi, Catalogo de' vescovi di Telese, Soc. Tipografica, Napoli 1827; G. Russo, Di un dichiarato nemico del Sommo Pontefice addivenutone involontario apologista, in «La Scienza e la Fede», XXXVII:8, Napoli 1877; F. Valesio, Diario di Roma, vol. VI, Longanesi, Milano 1979; F. Vecchietti e T. Moro, Biblioteca picena, o sia Notizie istoriche delle opere e degli scrittori piceni, libro III, Quercetti, Osimo 1793; G. Zigarelli, Storia della Cattedra di Avellino e de' suoi pastori, vol. II, Stamp. del Vaglio, Napoli 1856.
- Ispezione su carni da macello
Il Socio dott. Armani scrive: Desidero uno schiarimento circa quanto vengo esponendo a cotesta R. Società ed Accademia. Qui a Capracotta (Molise) si fa un'abbondante macellazione di ovini; ma stante le condizioni attuali di mancanza di animali da carne, da qualche macellaio un po' più spesso è stata macellata qualche capra, fin qui tollerata. La Giunta Comunale con recente deliberazione stabilì che per la macellazione delle capre, i macellai si dovessero provvedere anzitutto di un permesso speciale dal Municipio ed inoltre tale permesso dovesse essere confermato dal veterinario, il quale dopo la visita sanitaria dell'animale vivo e morto, ne avrebbe fissato il prezzo d'accordo coll'assessore delegato. E così mi si dà ordine che trovando negli spacci di carne di capra, non denunziata al Municipio e senza averne il macellaio avuto il relativo permesso, l'avessi fatta sequestrare. Ora io domando: 1° Fra i provvedimenti, che un Municipio può prendere circa il servizio delle carni, può dar disposizioni per il sequestro di carni di una data specie di animali, che per quanto non denunziate, sono sane? 2° Secondo la deliberazione della Giunta debbo io sequestrare la capra, che per quanto non denunziata, è sana e perciò da ammettersi al consumo? A me sembra che la deliberazione della Giunta esorbiti per quanto riguarda il sequestro, e credo che la carne, sebbene non denunziata sia da vendersi a prezzo conveniente, salvo a dichiarare in contravvenzione il macellaio per aver omesso la denuncia per ottenere il permesso di macellazione. Con ossequio. Capracotta (Campobasso), 17 febbraio 1904. Il Presidente osserva che un Municipio ha sempre facoltà di stabilire per il locale servizio di ispezione delle carni da macello tutte quelle disposizioni che gli paiono opportune. Agussi, Cenerelli, Minciotti e Tabusso si associano all'opinione del Presidente, aggiungendo che il veterinario comunale deve ottemperare sotto tutti i riguardi agli ordini datigli. Il Segretario Generale non può non condividere le opinioni emesse dal Presidente e dagli altri Soci che dopo di questi hanno preso la parola; ma trova però non aver poi tutti i torti il Socio Armani quando dice sembrargli che il Comune esorbiti un poco dall'onesto e dal legale facendo sequestrare e distruggere della carne sana. Con tanto depauperamento fisico che c'è nella razza umana, non c'è proprio bisogno che si distrugga carne sana. Gli pare quindi che il Comune di Capracotta farebbe bene ad accettare il consiglio del suo veterinario consorziale, metter cioè in contravvenzione l'esercente; che non ha chiesto la voluta autorizzazione, ma lasciar consumare la carne di capra. Diamine! – conchiude ridendo il Segretario Generale – proprio in un Comune che si chiama di Capra...cotta non si permetterà il consumo della capra che certamente si mangia... cotta? Fonte: Ispezione su carni da macello, per lo spaccio di carne ovina e caprina, in «Giornale della Reale Società ed Accademia veterinaria italiana», LIII:13, 26 marzo 1904.
- Nunziatina la Salarola
Il mio racconto è una piccola testimonianza; sicuramente una storia minima di quello che accadde negli anni terribili e successivi della Seconda guerra mondiale. Sono nato nell'anno 1940, durante il quale l'Italia, a fianco della Germania, dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra ed entrò nel conflitto mondiale. Sostenere che la guerra non abbia influito sui nostri percorsi di vita, non è possibile. Con la fine della guerra, i cannoni si spensero, ma le ferite sono rimaste e per alcuni la guerra non è mai finita. Sono trascorsi molti anni e i ricordi della mia infanzia sono ancora nella mia memoria. Feci il mio primo viaggio alla fine dell'anno 1945, su un traìne (carro), per andare in Puglia nella città di San Severo dove si trovavano i nonni paterni e parte della famiglia. Il viaggio durò quattro giorni. Di notte si dormiva nelle cosiddette taverne che erano delle località prestabilite per la sosta di persone ed animali. Lo zio Angelo, il fratello maggiore di papà, guidava il carro. Poi, per la notte, lo zio preparava un piccolo giaciglio sotto le stanghe del carro, dove potevo dormire vicino a lui. A San Severo frequentai le prime due classi delle elementari. Mi guidava nella lettura la nonna Peppinella. – Lorenzo, – mi richiamava – porta il segno con il dito –, mentre era intenta a liberare le sue calze dalle pulci. C'erano, infatti, molte pulci nell'ambiente ed era necessario fare con frequenza il bagno in una tinozza. La nonna era maestosa ed imponente nelle sue lunghe gonne, con i capelli leggermente ondulati raccolti sulla nuca. A tavola, per il pranzo, dove ero seduto tra la medesima ed il nonno Leonardo, distribuiva le porzioni della carne: «Questa a Lunàrde (Leonardo)», il nonno, «quest'altra ad Angelo», il figlio maggiore. E così di seguito, secondo l'età degli altri componenti della famiglia. La forchetta passava sopra il mio piatto e i miei occhi la seguivano, ma non si posava, se non alla fine, con una piccola porzione di carne. La stessa nonna, per tutto il mese di maggio, alle ore cinque del mattino, mi sollecitava a seguirla: – Lorenzo, alzati che dobbiamo andare alla messa alla chiesa di S. Antonio. Dopo il secondo anno delle scuole elementari tornai a Capracotta, perché la mamma mi volle con sé insieme agli altri due figli Pina e Michelino. Diceva, con una espressione poco elegante ma piena di orgoglio: – Dove mangiamo in tre, possiamo mangiare anche in quattro – per giustificare la decisione di aver voluto a Capracotta, presso di sé, i tre figli. Completai il ciclo della scuola elementare con il maestro Romeo. Insegnante molto bravo quanto severo. Spesso eravamo impreparati, e questo accadeva soprattutto durante la stagione invernale; come risposta ordinava a tutti di portare gli sci a scuola, che altro non erano che due pezzi di legno di faggio stagionato con la punta un poco rialzata, i quali andavano ad alimentare la stufa dell'aula di classe. In aggiunta c'era poi la punizione con la "spalmata": una striscia di legno, sempre di faggio, ben levigata che veniva data sul palmo della mano per cinque, dieci, venti volte secondo la gravità dell'errore. Rimasero famose quelle che prese Eutimio, il quale, da vero sannita, non cedette mai, neanche ad un pur piccolo lamento, lasciando insoddisfatto il maestro. Non solo, ma Eutimio aveva anche l'abilità di evitare il colpo della spalmata che invece andava a colpire dolorosamente la gamba del maestro. Al maestro Romeo piaceva suonare la fisarmonica e spesso ci faceva cantare "Il Piave mormorò, non passa lo straniero", accompagnando la celebre canzone patriottica con le note del suo strumento musicale. In quella classe mi fu compagno di banco il buon Celeste Curdìsche. Il maestro Romeo lasciò il nostro paese perché vinse il concorso da direttore didattico per la sede della città di Teramo. Alla mamma cercavamo di dare fastidio il meno possibile. Il nostro tempo era occupato, oltre che dagli obblighi scolastici, essenzialmente dai giuochi di piazza che erano diversi per ogni stagione. A primavera si incominciava con zompacuavàglie. Si andava a scuola al mattino prima dell'orario dell'entrata e, appoggiate le cartelle a terra, si componevano le squadre. Quelle più adeguate per il gioco erano composte di tre ragazzi ognuna. Si tirava alla conta e la squadra che usciva a sorte si disponeva in fila a mo' di schiena di cavallo. I componenti dell'altra squadra, con una lunga rincorsa, saltavano cercando di restare in equilibrio. La prova terminava quando qualcuno di quelli che stava sotto, per l'eccessivo peso cedeva oppure qualcuno di quelli che stava sopra perdeva l'equilibrio e cadeva giù. Con la chiusura della suola iniziavano altri giochi; tra essi quello che maggiormente ci teneva impegnati era il calcio. Interi pomeriggi si restava al campo sportivo, pur essendo lo stesso pieno di buche e di "pizze" di cacca di vacche che vi pascolavano liberamente. Tra i giochi di strada, cosiddetti minori, pur sempre divertenti, ricordo quelli a peschìtte, una forma semplificata del baseball americano, dove la palla veniva sostituita dal peschìtte, che era un pezzo di legno da colpire con una mazza; a "bottoni"; a nascondino, tra le mete di grano durante la trebbiatura; alla "voga". I giochi poi venivano intervallati con le scorribande tra i cespugli della Guardata per la ricerca dei ravascìne (uva spina) e per la raccolta delle peràzze (perastre) giù alla Difesa. Il mese di giugno poi era il più atteso perché portava le prime feste religiose: sant'Antonio e san Giovanni. Quella di san Giovanni era la più ricca di avvenimenti. Per tutta la giornata si poteva visitare la fiera degli animali, che si svolgeva lungo il costone dove attualmente è ubicato il serbatoio dell'acqua. Dopo pranzo si organizzavano le corse dei cavalli e degli asini: i primi partivano dal Ponte di Ferro e i secondi dalla fonte del Cummunìce. Quella degli asini era la più divertente ed allegra. Tommaso, il figlio di Incoronato il bastaio, poneva sotto la coda del suo asino un grosso cardo per sollecitarlo a correre. I giochi si concludevano con lo scivoloso albero della cuccagna tra gli applausi per chi era riuscito ad afferrare il prosciutto posto alla sommità del palo. La mamma, frattanto, aveva ottenuto la concessione governativa per la rivendita di sale e tabacchi, con la quale, insieme alla modesta pensione di vedova di guerra, cercò di crescere la famiglia. Non so dire se eravamo sotto o sopra la linea della povertà. Ma la miseria, per così dire, non pesava, per il semplice motivo che non sapevamo che cosa fosse la ricchezza o il benessere. La guerra ormai era alle nostre spalle e la ricostruzione del paese era cominciata ed andava avanti con molti sacrifici della popolazione. L'attività principale degli abitanti era l'agricoltura. Il prato della Guardata era pieno di animali che pascolavano: vacche, cavalli, muli, capre, asini. La nostra famiglia non esercitava l'attività agricola, ma commerciava il carbone. I pochi terreni che possedeva erano di difficile coltivazione. La mamma cercò di mettere a coltura qualcuno di essi, ma dopo qualche anno dovette smettere per le eccessive difficoltà che incontrò. Io, la sorella Pina e il fratello minore Michele avevamo l'incarico di sostituire la mamma presso la rivendita per darle l'opportunità di preparare il pranzo. A dire il vero però, la più impegnata era la sorella, la quale, dopo aver fatto l'esame di ammissione, aveva lasciato la scuola pur avendo delle ottime capacità per lo studio. Quando eravamo alla bottega io, Pina o Michelino, gli amici venivano a farci compagnia; allora il locale diveniva un posto di intrattenimento, di chiacchiere, di ingenui pettegolezzi. Nacquero anche degli amori, alcuni leggeri e transitori, altri duraturi che sono divenuti di vita. Quanta gente è passata per la bottega, con o senza soldi, perché a molti piaceva fumare. La mamma faceva credito a chi non poteva pagare subito, segnando il debito su un libretto dalla copertina nera, pronto a scomparire quando arrivava voce che in paese era giunta la Guardia di Finanza di Agnone. Vi erano personaggi bizzarri. Il veterinario Turchetti, romagnolo verace di ampia cultura, inveterato fumatore, era uno di questi: entrava e allargava sul bancone un fazzoletto colorato di 50 centimetri per 50 sul quale versava e mescolava i due trinciati di tabacco, quello comune e quello forte, che poi avvolgeva nelle cartine per farne le sigarette da fumare. La mamma, che ormai tutti chiamavano Nunziatina "la Salarola", a mezzogiorno lasciava il negozio per andare a casa a preparare il pranzo, sempre con la solita raccomandazione: – Non chiudete, aspettate che passino Achille, il segretario comunale, e Arnaldo, l'esattore. Questi erano clienti da tenere in massima considerazione, perché assidui fumatori; fra l'altro avevano la fisima di tastare i pacchetti, perché dicevano di gradire le sigarette morbide. Quando c'era la necessità di andare a fare il pane al forno, nel primo turno della notte, si sentiva la voce di zio Pasqualino il fornaio sotto la finestra della camera da letto: – Nunziatina, Nunziatina. – Lorenzo, – mi svegliava la mamma, perché dormivo nella sua camera – sta chiamando Pasqualino, affacciati e digli che vado subito. Questo succedeva anche quando c'era la bufera di neve ed era possibile vedere zio Pasqualino avvolto in una piccola mantella di panno di lana tirata sulla testa. Zio Pasqualino era un uomo speciale, garbato e pieno di odore di farina, sempre pronto a dare consigli a tutti. Si vedeva con il vestito della festa soltanto nel giorno di sant'Anna (26 luglio), in onore della quale organizzava ogni anno la festa. Le chiamate, durante la notte, non erano solo quelle del fornaio. I camionisti Antonio e Peppe Tagliacoccia avevano l'abitudine di partire nelle ore della notte per arrivare a Pescara verso l'alba, scaricare la legna o il carbone e ripartire subito per Capracotta. Spesso accadeva che si trovavano sprovvisti di sigarette e la soluzione immediata era quella di suonare il clacson in direzione della finestra dove sapevano che dormiva la mamma, la quale riconosciuto il segnale, buttava il pacchetto di sigarette dalla finestra, mentre Antonio la rassicurava: – Poi viene Lauretta a portare i soldi. – Lauretta era la moglie. L'arrivo della neve, annunciato dal volo basso dei passerotti, era sempre un evento felice per noi ragazzi. Nei giorni di forte bufera non si andava a scuola e si restava in casa con il naso appiccicato al vetro della finestra. Il pensiero correva ai giorni successivi quando, cessata la bufera, si poteva andare a sciare. Durante il periodo invernale, la mamma si alzava verso le ore sei del mattino per preparare il fuoco da cui ricavare la brace che doveva alimentare il braciere del negozio. Quando c'era la bufera, che accadeva spesso, trovava la porta del negozio ostruita dalla neve. Allora si fasciava la testa con la sciarpa di lana nera, per evitare che il vento la portasse via, e con la pala che le prestava zio Enrico il calzolaio, faceva il passaggio per entrare. Il primo a presentarsi alla bottega era Antonio Codì. – Nunziatina, – esordiva – dammi una sigaretta –, che all'epoca si potevano vendere anche sfuse – e non la segnare perché mi ricordo io. Ne fumava più di una al giorno, ma sempre una alla volta ne prendeva e le pagava qualche giorno dopo. Non è mai accaduto di aver omesso dal conto qualcuna quando decideva di pagare. Fu una persona onesta. Comunque, per la mamma non erano quelle le giornate peggiori. Il giorno più triste ed angosciante era quello della commemorazione dei defunti; ella non andava al cimitero come tutti facevano, ma restava a casa che riempiva di ceri accesi; e saliva e scendeva le scale in continuazione con evidente agitazione. Non trovò mai il sereno distacco dal ricordo degli avvenimenti che l'avevano coinvolta da quel triste anno 1945, nel quale le fu comunicata la morte di nostro padre. Il suo pensiero andava sempre a lui per non aver avuto una civile sepoltura e a noi figli per non averlo mai conosciuto. Durante il periodo della nostra prima infanzia, nostro padre fu sempre impegnato per esigenze militari prima in Albania, poi in Grecia, dove fatto prigioniero dai tedeschi nell'anno 1943, fu portato in Germania. Nel mese di marzo dell'anno 1945, con un barbaro pretesto, fu ucciso, insieme ad altri internati militari, dalla furia omicida nazista, nella città di Hildesheim, nel cui cimitero furono sepolti in una fossa comune, senza nomi ma con la semplice indicazione "208 sconosciuti". Questa è l'eredità che abbiamo ricevuto dalla guerra: un ricordo che si rigenera e mai si annulla. La mamma visse con l'animo perennemente addolorato, triste, chiuso al sorriso, ma non disperato. Fu donna di fede e di preghiera; la sera recitava il rosario e ogni venerdì della settimana, sul camino di casa, accendeva una lampada votiva per i defunti: un bicchiere a forma di calice, pieno di acqua per oltre la metà e per il resto di olio, sul quale poneva lo stoppino che bruciava, fissato su un pezzetto di sughero. La mamma, Nunziatina "la Salarola", morì all'età di 77 anni in un ospedale di città; ci fu detto che durante la notte, nell'ultimo tratto della sua esistenza, le fece compagnia un frate cappuccino, recitando il rosario. Ciao mamma. Lorenzo Potena Fonte: L. Potena, Nunziatina la Salarola, in AA.VV., I racconti di Capracotta, vol. IV, Proforma, Isernia 2013.
- Antonio Battilo, l'eroe di Palazzo Capracotta
Questa testimonianza ci è stata fornita direttamente dalla voce dell'interessato Antonio Battilo, classe 1939, per il tramite di un nostro lettore del blog, il caro amico Luigi Battilo. La famiglia Battilo, pescivendoli ambulanti per tradizione familiare al largo Santa Croce a Portici, per generazioni hanno sempre abitato a Palazzo Capracotta, meglio conosciuto come 'o palazzo 'e Peppe 'e Catiello, nonno del dott. Saldamarco. Ricordiamo ai nostri lettori che la struttura attuale con pianta a libro risale più o meno agli inizi del '700. Appartenuto alla famiglia Capece Piscicelli, duchi di Capracotta, ha rivestito nel corso dei secoli varie destinazioni d'uso, prima sede della Curia, poi prigione e poi sede del Municipio in epoca borbonica e post-unitaria. Vi pubblichiamo anche due mappe, una di fine '700 ed un'altra di fine '800 dove si possono rilevare lo stato del palazzo all'epoca con la presenza del giardino al suo interno. Ci racconta Antonio che lui e la sua famiglia vivevano al primo piano insieme ad altre famiglie, tra cui quella del dott. Saldamarco. Le condizioni di vita erano al di sotto degli standards attuali ovvero c'erano bagni comuni ma comunque c'erano due fontane e due giardini su due livelli. Il signor Antonio ha vissuto tutta la sua infanzia e la sua adolescenza fino al matrimonio nel Palazzo e ricorda con viva commozione i vari eventi che si sono succeduti. Ricorda le botteghe storiche che erano presenti sulla facciata del Palazzo, ovvero botteghe di macelleria della famiglia Iodice, detto 'o Signurino, che erano anche proprietari nello stabile. Nel cortile interno c'era la bottega per le tende da paracadutista del sig. Armando Senatore e verso l'angolo della strada la bellissima salumeria dell'avvocato Coppola, con giardino interno, padre del dott. Gabriele Coppola. Nel Palazzo la famiglia Battilo era molto numerosa e lo stesso Antonio ci raccontava che in una stanza del Palazzo vivevano in nove. Ma l'episodio più significativo della vita di Antonio avvenne all'incirca in un'estate, forse, del 1962, quando durante la notte sentì un boato tremendo e si accorse che parte del solaio della sua stanza cadde sopra di lui. Non convinto, visto il clamoroso boato, si precipitò al piano di sopra in corrispondenza dell'appartamento della famiglia Iodice constatando che tutti loro erano rimasti sotto una massa di detriti e calcinacci. Nonostante l'oscurità e la polvere sollevatasi riuscì a trarre in salvo i genitori ed i figli che erano rimasti sotto. Intanto gli altri abitanti del Palazzo avevano chiamato i vigili del fuoco ma l'improvviso intervento di Antonio riuscì sicuramente a salvare delle vite umane. La conseguente inalazione della polvere provocò ad Antonio, una volta giunto sul ballatoio del palazzo, uno svenimento e fu necessario l'intervento di alcuni sanitari giunti sul posto. L'accaduto fu ricordato su diverse testate giornalistiche nelle cronache locali (speriamo di trovare i giornali dell'epoca) ed Antonio Battilo fu convocato in Comune qualche settimana dopo per ricevere un encomio pubblico ed anche una somma in denaro. Dopo quest'episodio e visto l'ormai stato di precarietà del Palazzo stesso, tutti gli abitanti furono trasferiti a via Tironi di Moccia. Quello che resta dell'ormai antico palazzo sta solo nella memoria di Antonio e di chi ci ha abitato o vissuto per un po' della sua vita. Luigi Cozzolino Fonte: https://www.bloginresina.it/, 2014.
- Paiele
Alle prime ore del pomeriggio quando il sole era ancora alto e il caldo forte per la strada compariva Paiele curvo a passare la scopa di saggina, anch'essa curva per l'uso. A volte indossava un grembiule a volte no, la camicia infilata nei pantaloni sottolineava l'arco deforme della schiena evidenziando le sproporzioni del corpo basso e storto piantato nei larghi scarponi che al passo gli davano una rigidità innaturale. Con diligenza egli raccoglieva foglie, fieno, pietre e sterco di vacche o di cavalli, ne faceva mucchi che poi ripassava a prendere. Affaticato dal caldo raramente alzava il viso per scambiare qualche parola con i pochi passanti, per tutto il tempo del suo lavoro teneva la bocca sdentata appena aperta in maniera che il mento già lungo e obliquo rasentava il petto. S'interrompeva a tratti per asciugare il sudore con un ampio fazzoletto passato sotto il berretto logoro e sulla fronte per seguire chissà quali ragionamenti in un alterno soliloquio, prendendosela anche con il vento che gli complicava la fatica. Schivo con tutti, sembrava avere fretta di finire il suo lavoro e mal tollerava interruzioni e impedimenti, accettava di buon grado solo un bicchiere di vino e poi ripartiva con il suo umile carico in discesa. Flora Di Rienzo Fonte: F. Di Rienzo, Piccolo florilegio, Capracotta 2011.
- Un pezzo di Scozia e Irlanda
Guido Piovene nel 1957, nel suo "Viaggio in Italia", definì l'Alto Molise «un pezzo di Scozia e Irlanda». Quarantacinque anni dopo, l'Alto Molise è ancora così verde: verde, ampio e bellissimo. Da quest'anno vanta in più un invidiabile primato: è l'angolo più "salubre" d'Italia. La Asl dell'Alto Molise è, infatti, quella dove i decessi dovuti a fattori evitabili, in testa a tutti la malasanità, ma anche le tossicodipendenze, gli incidenti sulla strada, gli infortuni sul lavoro o domestici, gli effetti dell'inquinamento, si attestano, presi complessivamente, al valore minimo. Qui ogni anno i decessi che avvengono per motivi diversi dalla vecchiaia o da una malattia incurabile colpiscono 120,2 uomini e 64,8 donne ogni 100 mila abitanti, a fronte di un dato medio nazionale, rispettivamente, di 170,9 e 70. Lo certifica la ricerca "Prometeo. Atlante della sanità italiana" che, dal '99, registra questo originale indicatore della qualità della vita: le percentuali di morti evitabili, appunto, nei distretti sanitari. Nel 2002 il tasso minimo si rileva nella Asl alto-molisana di Agnone-Carovilli-Capracotta. Ma qual è il segreto che si nasconde dietro queste cifre? È grazie allo sviluppo o, al contrario, grazie all'atavica povertà, che in quest'angolo di Italia si muore meglio, e meno, che altrove? Usciti dall'autostrada Roma-Napoli, ci si lascia alle spalle Isernia: qui la I.T.R., con i suoi capannoni, è l'unica grossa industria della provincia e ci finiscono a lavorare tutti, o quasi, i ragazzi che non vogliono emigrare. La deviazione che porta ad Agnone, il capoluogo del distretto sanitario, sale su per i tornanti, tra mucchi di neve e boschi di faggi e di abeti bianchi. Basta lo sguardo, e basta respirare, per capire che da queste parti molti fattori di rischio sono ridotti al minimo. Non ci sono discoteche, né morti del sabato sera, né spaccio di droghe. Non ci sono cantieri né altre fabbriche: niente morti sul lavoro. L'aria è cristallina: questa è una Asl di montagna, il territorio si staglia in media sopra i 1.100 metri. L'Alto Molise ha conosciuto una povertà disperata: a Capracotta è stato uso fino all'altroieri festeggiare la festa della patrona ogni tre anni, per mancanza di soldi. Ma proprio in questo angolo di Italia oggi si coltiva, anche, una forma buona e civile di sviluppo: pure le morti per malasanità, infatti, sono ridotte ai valori minimi. Si perdono 31,5 anni di vita ogni 100 mila per carenza di prevenzione primaria, a fronte degli 80,7 della Asl dell'Alto Friuli che detiene il primato negativo. Agnone, 6 mila abitanti, ha un cinema, un teatro e un fascino originale: perché nel Medioevo vi arrivarono drappelli di veneti in fuga dalla Serenissima, e importarono l'arte orafa, l'industria della fabbricazione delle campane, e certi fregi a forma di leone di San Marco che ornano ancora le facciate delle case di pietra serena. L'ospedale San Francesco Caracciolo è il cuore del sistema sanitario. Due sale operatorie, una sala-dialisi con 23 letti (in cui arrivano pazienti anche dalla Puglia), 101 posti letto, più altri 18 per riabilitazioni e lungo-degenze: non c'è segno di sciali, ma di cura sì, le stanze, azzurrine, sono al massimo a due letti e sono dotate ognuna di bagno e piccolo televisore. L'attrezzatura diagnostica arriva fino alla Tac spirale. Giovanni Di Pilla, direttore generale della Asl, mostra i risultati di una rilevazione effettuata ai primi di gennaio: i tempi di attesa per una visita o un esame vanno da zero giorni, per una mammografia o una lastra, una spirometria o un accertamento neurologico, fino a un massimo di otto, per un esame doppler. Dunque, ecco perché qui si muore meno per diagnosi tardive. Il dottor Giuseppe Attademo, cardiologo e responsabile locale dell'Osservatorio regionale per la qualità dei Servizi Sanitari, racconta che nel '99 hanno distribuito un questionario per raccogliere lagnanze e richieste. Da quei questionari è nata la ristrutturazione dell'ospedale, vecchio di cinquant'anni, costata quattro miliardi ed effettuata in soli 18 mesi. In prospettiva, a tre chilometri da qui nascerà un nuovo nosocomio e questo edificio arioso e quieto diventerà il cronicario del quale la zona ha bisogno urgente: l'Alto Molise è, dicono con una battuta, Asl campione d'Italia. Maria Serena Palieri Fonte: M. S. Palieri, Un pezzo di Scozia e Irlanda, in «L'Espresso», XLVIII:7, Milano, 14 febbraio 2002.
- L'antica lana di Capracotta
Nei secoli scorsi la rilevanza economica della transumanza era tale da rendere necessaria una specifica istituzione del Regno di Napoli: la Regia Dogana della mena delle pecore di Foggia. Ma il quesito a cui voglio trovar risposta è: in che termini la transumanza prese realmente piede a Capracotta? Natalino Paone, ne "La transumanza nel Molise tra cronaca e storia", afferma che: In questo centro la pastorizia fu presente sin dall'epoca sannitica, ma l'attuale paese si fa risalire a poco prima del Mille e la sua crescita rapida e forte viene però collegata alla grande transumanza aragonese. Capracotta ricevette «incremento della popolazione, della prosperità e del progresso intellettuale» solo dalla transumanza organizzata, tanto che al censimento del 1522 i fuochi risultarono in numero di 118, salendo nel 1575 a 248. Una popolazione più che raddoppiata in appena 53 anni! E più che raddoppiato risultò, sempre nello stesso periodo, il numero dei contratti di compravendita di feudi, movimentando un mercato in precedenza a livelli molto modesti. Addirittura i feudi molisani di alta montagna furono molto ricercati da nobili casati napoletani, i quali nelle masserie armentizie trovarono le principali fonti di reddito. Questo tipo di masserie rientrò anche nei capitoli matrimoniali: la nobildonna Aurelia d'Ebulo, sposando nel 1583 il cugino, ebbe appunto tra i capitoli della dote una masseria armentizia a Capracotta di ben 5 mila capi. Gli effetti della transumanza si fecero notare anche nei settori politico e culturale e nei campi amministrativo e militare, in cui si distinsero molti cittadini di Capracotta. Possiamo dire oggi che dalla transumanza, in modo diretto e indiretto, era nata una borghesia intellettuale, commerciale e artigianale, nonché la feudalità che arricchiva il nucleo urbano del primo palazzo baronale costruito proprio nel XV secolo. Accanto ai pastori, alla borghesia, e alla feudalità, la Chiesa. Molte furono le chiese molisane che nel periodo di maggior fulgore della transumanza aragonese e post-aragonese divennero anche aziende armentizie iscritte alla Dogana di Foggia come locate, ossia come proprietarie di pecore che partecipavano alle migrazioni stagionali. Per restituire al lettore quanto detto dal Paone, propongo due testimonianze scritte, una del 1472 e l'altra del 1548. Il primo documento sul commercio della lana capracottese che ho rinvenuto sta in un libro mastro conservato presso l'Archivio di Stato de L'Aquila. Si tratta di un manoscritto compilato negli anni 1471-73 e redatto da una sola mano in scrittura mercantesca. Pur essendoci giunto in buono stato di conservazione, esso è adespoto, anepigrafo, acefalo e mutilo: fondamentalmente si tratta di una sorta di registro in partita doppia. Il lavoro di trascrizione e ricostruzione fu effettuato da Nicola Marini per conto della Deputazione abruzzese di Storia patria e, a proposito di Capracotta, all'anno 1472 è scritto nel libro mastro che: «dezine 140 de lana portò la state passata da Crapacotta quj [...] e de' avere fino a dj detto celle 278: sonno lj facemo boni per vittura de dezine 278 lana Carfagna portò da Lanzano del sig. secretario la state passata in balle 10». Si evince che nel XV secolo il venditore più agiato di Capracotta appartenesse alla famiglia Carfagna - prima che questa migrasse in Campania - ma non è facile capire a quanto ammontassero le celle di lana, trasportabili in convoglio, e che quindi differiscono dalle balle. Per avere un'idea più precisa della quantità di lana prodotta e del profitto derivante dalla sua commercializzazione, propongo, con l'aiuto dei registri notarili, un secondo documento datato 9 giugno 1548, allorché Giovanni Salmezza di Bergamo vendette a Fabiano Quaranta di Capracotta «ex causa venditionis cannarum 21 stametti bergamani fini variorum colorum pro pretio ducatorum 59», da cui si ricava il prezzo unitario di 2,8 ducati la canna. I tessuti bergamaschi erano infatti quelli maggiormente scambiati fino al XVI secolo e, a quanto pare, i panni stametti - costituiti per l'appunto di stame, cioè la parte più lunga e consistente del fiocco di lana - piacevano molto ai produttori capracottesi, dimostrando che la nostra filiera si spingeva fin nella Lombardia pedemontana ed era piuttosto moderna, visto che produceva, acquistava, lavorava e vendeva prodotti finiti in lana di particolar pregio, di vario colore e di complessa manifattura. Francesco Mendozzi Bibliografia di riferimento: S. Bucci, Dalla cultura della transumanza alla società post-industriale. Progresso e mutamenti nella Regione Molise, Vita e Pensiero, Milano 1988; L. Casilli, Aspetti socio-economici della transumanza nel secolo XVIII, in E. Narciso, Illuminismo meridionale e comunità locali, Guida, Napoli 1989; A. Di Nucci, I prezzi e le merci a Lanciano nel Cinquecento, in P. Pierucci, Congiunture e dinamiche di una regione periferica. L'Abruzzo in età moderna e contemporanea, Angeli, Milano 2017; N. Marini, Il libro mastro di Pasquale Di Santuccio, Colacchi, L'Aquila 1998; J. A. Marino, L'economia pastorale nel Regno di Napoli, trad. it. di L. Piccioni, Guida, Napoli 1992; F. Mendozzi, Guida alla letteratura capracottese, vol. I, Youcanprint, Tricase 2016; G. Molinaro e M. Pasquarosa, Professazione e commercio della lana: ruolo dei luoghi pii e dei locati di Capracotta nel XVIII secolo, in AA.VV., Considerazioni sulla transumanza, Ciolfi, Cassino; N. Paone, La transumanza nel Molise tra cronaca e storia, Iannone, Isernia 1987; M. Romano, Potere, patrimonio e attività economiche dei Caracciolo di Martina nel primo trentennio dell'Ottocento, in D. Marrara, Ceti dirigenti e poteri locali nell'Italia Meridionale (secoli XVI-XX), ETS, Pisa 2003; R. Rossi, La lana nel Regno di Napoli nel XVII secolo. Produzione e commercio, Giappichelli, Torino 2007.
- Der Spiegel non si meraviglia che Schettino fosse italiano
Pietransieri è un borgo abruzzese dove vado spesso. È una minuscola frazione del comune di Roccaraso arroccata al di qua della Majella, sul monte Tocco, da cui si gode di una vista spettacolare sulla valle del Sangro e sui monti dell'Alto Molise, dove ci sono Capracotta e Pescopennataro. Da piccolo ci passavo le vacanze, e perciò ho ricordi di quel luogo che annovero tra le mie cose più preziose. Almeno una volta all'anno devo vedere Pietransieri da Capracotta o viceversa. Meglio se vado a Pietransieri, e in compagnia, così ci fermiamo anche a pranzare al ristorante "La Preta" per una consueta dose di cazzarielli con i fagioli, polenta con [inserisci qui il tipo di selvaggina locale disponibile al momento] e scamorza alla brace. Non è una marchetta, è che chiunque ha il dovere morale di sapere quanto si mangia bene lì. Veniamo al dunque: il 21 novembre del 1943 passarono per Pietransieri le truppe tedesche del maggiore Schulenburg in fuga dagli Alleati che erano appena sbarcati sulle coste tirreniche del Sud. Per rappresaglia, i tedeschi rastrellarono tutte le abitazioni di Pietransieri, radunarono gli abitanti nel vicino bosco di Limmari e li mitragliarono tutti: 128 persone, delle quali 34 bambini e un neonato di un mese. La neve ricoprì e nascose i cadaveri nel bosco fino alla primavera successiva, perché Pietransieri era un borgo isolato, e non c'era nessuna ragione per passarci. A Pietransieri oggi c'è un piccolo sacrario che custodice i corpi e la memoria storica delle vittime di questa cosa per cui io non riesco a trovare una parola adatta. Atrocità mi sembra fin troppo indulgente. Forse, più che per un pranzo alla Preta, Pietransieri vale una visita per quel sacrario, architettonicamente insignificante, ma moralmente un capolavoro. Ognuno di quei nomi è un giudizio storico dalla forza spaventosa, ognuna di quelle date di nascita e di morte è una condanna tuonante e feroce contro qualsiasi crimine di guerra, non solo questo. Dispiace sempre un po' tirare fuori argomenti del genere per mettere a zittire i tedeschi, soprattutto quando, riferendosi a un errore di un singolo (Schettino), pretendono di definire la "psicologia dei popoli", come nell'articolo di "Der Spiegel", e si chiedono il senso di radunare in unione monetaria la perfezione teutonica e il terzo mondo mediterraneo, cosa che non viene detta tout court ma traspare inequivocabilmente da ogni virgola di quell'articolo, soprattutto dall'invito a visitare Napoli o il Peloponneso. A un idiota che dà per scontato che una tragedia del genere non sarebbe accaduta se al comando della nave ci fosse stato un tedesco al posto di Schettino, verrebbe troppo facile ribattere che a Pietransieri sarebbero state risparmiate scariche di colpi su bambini e neonati se ci fosse stato un maggiore italiano al posto di Schulenburg. Non è questa la mia intenzione, perché so che i codardi abbondano in ogni cultura di ogni tempo, e che tanti sono gli Schettino tedeschi quanti sono gli Schulenburg italiani (cosa che andrebbe spiegata anche a Sallusti che, col suo volgarissimo editoriale sul Giornale, riesce a replicare a un episodio di pessimo giornalismo con qualcosa di ancora più infimo). Cito l'episodio di Pietransieri solo perché a quell'idiota di Jan Fleischhauer, l'autore di quell'articolo su "Der Spiegel", mi piacerebbe far capire che nessun popolo può dirsi al riparo da generalizzazioni incaute e pericolose, e che io non mi aspetterei mai tali generalizzazioni da parte di un popolo che storce il naso e si rabbuia ogni volta che gli viene rinfacciata o anche solo ricordata la responsabilità dell'Olocausto, per esempio. Mi chiedo se l'Unione Europea sarà sempre così, caratterizzata dalle lamentele tedesche per ogni cosa che non sia all'altezza della loro nazione produttiva ed efficiente. Fino ad ora è sempre andata così, se non erro. Probabilmente per i tedeschi il resto d'Europa non è stato efficiente neanche quando si è dato da fare per ricostruire la Germania ridotta in ginocchio alla fine della Seconda guerra mondiale, o quando ha fatto piovere sul loro paese fiumi di denaro per aiutare economicamente la riunificazione. Totentanz Fonte: https://totentanz.wordpress.com/, 27 gennaio 2012.
- Quando si mangiava peggio
Oggi sul nostro pianeta c'è cibo per tutti. Siamo in grado di sfamare sette miliardi di persone. Nel 1800, quando eravamo "solo" un miliardo, alcuni, come il reverendo Malthus, ritenendo che le bocche si moltiplicano molto più rapidamente del cibo, sostenevano che per sfamare tutti occorreva controllare le nascite per mezzo della moral restraint, insomma con meno sesso. Come mai siamo riusciti a produrre così tanto cibo? In primo luogo abbiamo fatto enormi progressi nei trasporti e nella comunicazione; poi è aumentata la nostra capacità di conservare gli alimenti (conserve, refrigerazione, ecc.). Il resto lo hanno fatto i fertilizzanti, i trattori, la fecondazione artificiale degli animali, insomma l'applicazione della scienza all'agricoltura, che hanno fatto aumentare il cibo in modo gigantesco. Eppure sul nostro pianeta ci sono oggi persone che non mangiano abbastanza. Siamo abituati a immagini televisive scioccanti di bambini affamati. Ma ci sono molti bambini che non muoiono di fame, ma che non in grado di ottenere un cibo abbastanza nutriente per potersi sviluppare. La sotto-alimentazione è uno dei temi più trascurati nello sviluppo globale. Ci sono oggi quasi 900 milioni di persone (una persona su otto) sottoalimentate. Oggi l'agricoltura produce il 17 per cento in più di calorie per persona di quanto accadesse trent'anni fa, mentre la popolazione è aumentata del 70 per cento. Questo è sufficiente per dare ad ogni essere umano ben 2.720 chilocalorie per persona al giorno, secondo le stime della FAO. Alcuni Paesi consumano ben più di 2.720 pro capite. L'americano medio ne consuma 3.770, con risultati ben visibili (ma gli europei non sono molto distanti). In una decina di stati africani la media è inferiore alle 2.000 calorie al giorno. In Occidente sorge una nuova malattia, l'obesità, dovuta, almeno in parte, alle moltiplicazioni di snack che hanno portato ad una baldoria di mangiare non-stop. Ma nei Paesi sottosviluppati si fa la fame. Eppure non molto tempo fa anche nel nostro continente si mangiava male. Negli ultimi decenni del XIX secolo, nel cuore dell'Europa occidentale, in Francia, uno dei Paesi più ricchi del mondo, molte famiglie rurali vivevano nella miseria, con una dieta quotidiana che consisteva di zuppa, lardo e pane. La cucina contadina, a differenza dell'immagina romantica che molti hanno oggi (ricette antiche, cibo genuino, semplice e sano, un mondo che abbiamo perso, ecc.), era una cucina povera, priva di valore nutritivo e di vitamine, poco igienica. All'inizio dell'Ottocento in alcuni villaggi vicini a Zurigo, oggi una delle regioni più ricche del mondo, il pasto contadino consisteva in una poltiglia di grano al quale veniva aggiunto un po' di latte. Un Paese con le caratteristiche della Svizzera del 1800 sarebbe oggi classificato dalle Nazioni Unite come un avente diritto ad aiuti internazionali. Nel 1870, notava il conte Stefano Jacini nella sua famosa "Inchiesta agraria", nei comuni della provincia di Roma, «il vitto ordinario è quasi unicamente basato sul granturco. Questo cereale, ridotto in farina, viene impastato con acqua, e sotto forma di schiacciata, detta pizza, è cotto nel forno per fare il pane e servito in tutti i pasti quotidiani... l'alimentazione è sempre incompleta, sovente costituita da cibi malsani. Il grano e il granturco sono ordinariamente avariati, i legumi cattivi, il formaggio magro». Più a Sud, si stava peggio. La maggior parte dei contadini mangiavano pane fatto con farina di mais o di castagne. La pasta veniva consumata solo dai più benestanti. L'ufficiale sanitario di Capracotta, una piccola città del Molise, notava nel 1891 che i 5.000 abitanti vivevano in piccoli tuguri con le loro bestie. Trent'anni dopo, in Sicilia, la situazione era la stessa. La Commissione Parlamentare Faini rilevava che in una tipica casa contadina animali e esseri umani dormivano tutti insieme: i nonni, i figli, i nipoti, il mulo, l'asino, le galline e qualche maiale. Una sorta di porridge fatto, spesso con il granoturco, per riempire lo stomaco, era il pranzo abituale dei poveri contadini in gran parte dell'Europa. Di questo si nutrivano al mattino, di giorno e di sera, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Due giornalisti francesi, i fratelli Léon e Maurice Bonneff, raccontano la loro visita ad una casa operaia a Lille. Siamo nel 1908. Ci vivono una giovane famiglia. La donna ha 26 anni, ma ne dimostra cinquanta. Tossisce ininterrottamente. La stanza dove vive con il marito e i cinque figli è di quattro metri per due. Il marito parte per il lavoro alle cinque del mattino e torna alle sette di sera. Hanno la tubercolosi e non vivranno a lungo. Si stima che in quella zona la malnutrizione sia la causa diretta della tubercolosi nel 68 per cento dei 519 lavoratori interessati. La nobiltà, naturalmente, godeva di uno stile di vita completamente diverso. Questo era vero non soltanto a Londra, Parigi, Napoli e Berlino, ma anche per gli aristocratici "minori" in zone periferiche. Il geologo francese Barthélemy Faujas-Saint-Fond, in viaggio nella Scozia nel lontano 1784, ci ha lasciato un resoconto affascinante delle vivande disponibili a casa del suo ospite «Monsieur Mac-Liane», nell'isola di Mull nel Nord-Ovest della Scozia. «Mac-Liane» era certamente il generale Allan MacLean che aveva preso parte alla difesa del Quebec dagli eserciti rivoluzionari americani. MacLean era tutt'altro che ricco, ma il cibo che era in grado di offrire al suo ospite francese era eccezionale. Forse stava cercando di impressionarlo, e ci riuscì. La colazione del mattino consisteva in manzo affumicato, aringhe salate, burro, latte e panna, porridge; poi, latte mescolato con tuorlo d'uovo, zucchero e rum (ovviamente una specie di zabaione), marmellata di uva, mirtilli, frutti locali, tè, caffè, vari tipi di pane, e poi rum della Giamaica. A cena c'era una grande ciotola di zuppa di manzo, montone e pollo con avena, cipolle, prezzemolo e piselli seguita da un sanguinaccio di maiale (probabilmente il famoso black pudding) con molto pepe e zenzero, "eccellenti" fette di manzo alla griglia, arrosto di montone di alta qualità, patate cotte nel sugo di carne, polli, cetrioli e un chutney di zenzero, madeira, un pudding di farina di orzo, crema e uvetta greca. Finita la cena, servivano porto, sherry e madeira e un punch; poi formaggi e infine il tè. Faujas-Saint-Fond poi spiega che i 7.000 abitanti di Mull, principalmente pastori, andavano in giro senza scarpe e cappello (nel Nord della Scozia!), mangiavano avena e patate. E le donne (al contrario della figlia del generale) erano brutte per via «del clima e del cibo». Tale divario tra i ben nutriti e gli altri esiste ancora oggi. La scarsità di cibo è dovuta in parte alle catastrofi naturali e dalle guerre, ma soprattutto alla mancanza di infrastrutture agricole (strade, canali, irrigazione). Mancano gli investimenti in agricoltura che sono cinque volte più efficaci nel ridurre la povertà e la fame degli investimenti in qualsiasi altro settore. Poi c'è lo spreco di alimenti: secondo un rapporto FAO, un terzo di tutto il cibo prodotto non viene mai consumato. E così ci troviamo in questa situazione curiosa e terribile: un mondo diviso tra quelli che mangiano troppo poco e quelli, i cosiddetti fortunati, che mangiano una quantità eccessiva di cibo sbagliato. Donald Sassoon Fonte: D. Sassoon, Quando si mangiava peggio, in «Il Sole 24 Ore», Milano, 6 aprile 2014.
- Voccarusce 'mpanicce: ricetta, fatti, aneddoti e... curiosità!
Nei primi giorni di maggio, quando dalle nostre parti la primavera incomincia a farsi sentire, è solito notare il raccoglitore di voccarùsce inerpicarsi su per i nostri monti per raggiungere i vecchi stazzi alla ricerca della prelibata erba spontanea. Questo orapo selvatico ha sembianze simili allo spinacio e spesso si confonde con l'ortica, dal momento che solitamente crescono insieme. Una volta mondato e ben lavato va cotto in acqua salata e, al momento di scolare, fare attenzione a conservare l'acqua di cottura necessaria che, unitamente al pane raffermo o secco, darà il via alla 'mpaneccieàta, ovvero: amalgamare per bene. Tale operazione è opportuno eseguirla con un pestello di legno o, in mancanza, con un robusto cucchiaio purché di legno e terminarla solo quando l'impasto apparirà omogeneo. Nel frattempo, a parte, si fa soffriggere, con poca cipolla, la ventresca stagionata di maiale che si unirà alla 'mpanìccia e, con l'aggiunta di un pizzico di peperoncino e una buona spolverata di pecorino, il piatto è pronto. Questa ricetta, in altri tempi, conteneva la muscìsca (carne di pecora essiccata al sole) al posto della ventresca; ma, ormai, risulta introvabile e noi ci auguriamo che, chi conosca l'antico metodo per realizzarla, lo tramandi, al fine di non disperdere ciò che, allora, era necessità ed oggi potrebbe divenire turismo culinario. Re voccarùsce e tante altre erbe che crescono spontanee nel nostro territorio sono, o meglio, erano utilizzate da companatico in tanti piatti poveri, al fine di rendere più appetitoso il pane, quasi sempre duro se non stantio. Tra le tante, alcune si mangiavano anche crude, proviamo a ricordare (anche per sentito dire!): cieàmma-cieàmma o ciammarluótte, salvieàgge, fiùre de re paradìse, cassèlle, lambeàzzare, cuóppe-cuóppe, papeàmbare, pasctenàche, tieànne, ciacìvete, taratùffele, marruóina etc... quest'ultima usata (come la "genzianella") sia per stuzzicare l'appetito che per curare re varlìse (le escoriazioni) degli animali da soma. Menzione a parte merita la rapàneca. Questo particolare cardo selvatico, buono se mangiato prima di schiudere, veniva usato dalle ragazze (udite udite, oh giovani!) per rifiutare l'offerta di fidanzamento. Il malcapitato che riceveva il singolar dono era preso in giro dagli "amici" che lo canzonavano facendogli gli auguri per la bella rapàneca ricevuta. Insomma, tra tutte queste erbe si pasceva, si cresceva e ci si moltiplicava, all'insegna del detto: "Tùtte jèrve cuóglie, cuóglie e puó màgnatele che sàle e uóglie!". A riprova di quanto sia vero tale detto, si narra che un noto avvocato capracottese, esercitante in quel di Roma, recatosi un giorno alla ricerca di voccarùsce, ne trovasse in tal quantità che, oltre a farne una scorpacciata nei giorni di permanenza a Capracotta, ritenne cosa buona continuare la ghiotta abbuffata a Roma, unitamente al resto della famiglia. Fin qui, tutto bene! Se non che, l'uomo di legge, tornato a Capracotta, con fare saccente, si vantò della gran raccolta, suscitando stupore e incredulità in quanti lo stavano ad ascoltare, i quali dovettero sudare sette camicie per convincerlo che in quel periodo e in quel luogo, re voccarùsce non potevano assolutamente esserci. Probabilmente si trattava di altre erbe. L'avvocato, pur non del tutto persuaso, concluse: – Voccarùsce o non vaccarùsce, ije me r'aje magneàte e so' sctàte pùre buóne! Il detto fu suggellato dalla legge! Pasquale Paglione Fonte: P. Paglione, Voccarusce 'mpanicce: la ricetta, fatti, aneddoti e..., in «Voria», I:2, Capracotta, ottobre 2007.
- Tre cavalli e un somaro
Certo che nella mente di una persona di una certa età ne passano di ricordi di vita vissuta in sessanta-settant'anni d'esistenza. E le ore per ricordarsi meglio del passato sono quelle del mattino, verso le 5-6, quando non hai più voglia di dormire, ti rivengono in mente tutti i ricordi della fanciullezza, ricordi così lontani che poi svaniscono nella vita quotidiana di tutti i giorni. Sembra di avere una visione più limpida di tutti i ricordi lontani nel tempo. È così che molte mattine a letto mi ripassavo col pensiero ogni attimo, ogni momento della vita di tanti anni fa, e sfruttando questo barlume di memoria, mi sono accorto che avrei potuto descrivere con semplice austerità i quarant'anni di vita vissuti nel mio paese e precisamente a Capracotta nell'Alto Molise, a 1.421 metri sul livello del mare. Multiattività agricola Bè! facendo anche uno sforzo mentale, ho cercato di rimettere su quel periodo così agrodolce ma anche naturale di un'esistenza ormai lontana. "Multiattività agricola" è una parola difficile, e qui il giornalista, il romanziere, ci potrebbero fare addirittura una cronaca ben lunga, ma io con la mia semplicità mi limiterò a spiegare il significato della parola. Vivere in quei luoghi a 1.421 metri di altezza, e fare l'agricoltore come mestiere primario, non era tanto facile perché, per vivere, ci dovevi mettere tutti gli altri lavori che ti capitavano a portata di mano, e non rifiutare niente, altrimenti morivi di fame. Anche a spalare la neve d'inverno per 50 lire al giorno, e 200 lire, e anche 400 lire appena dopo la Seconda guerra mondiale. Sarebbe troppo lungo e noioso descrivere punto per punto tutte le privazioni ed i soprusi che si sopportavano per sbarcare il lunario. Di tanti lavori che si facevano, uno mi interessa ricordare in particolare, e far conoscere a chi avrà l'occasione di leggere questi modesti righi. Il carbonaio Un mestiere che aveva tutti i difetti immaginabili di questo mondo, perché era un mestiere pesantissimo, misero. Per riportare a casa qualche cento lire bisognava lavorare notte e giorno. Parlo dell'epoca in cui è toccato anche a me fare per parecchi anni quel maledetto lavoro, ossia dal 1930 al 1943. I cittadini del mio paese, quando arrivava l'autunno ed avevano finito i lavori agricoli rimettendo in casa tutto il ricavato che ti dà la terra in quei luoghi, cioè grano, patate, legumi, fieno per le bestie ecc., lasciavano le bestie in custodia alle donne e si apprestavano a fare per tre-quattro mesi invernali questo inumano lavoro. Era un periodo che se ne faceva tanto di carbone vegetale, perché aveva una grande risonanza nell'industria italiana, specie negli anni precedenti all'ultima guerra mondiale. Molte erano le aziende che si interessavano alla compera delle sezioni boschive. Anche a Capracotta c'erano delle piccole e medie aziende che si interessavano alla collocazione degli operai. Si formavano delle squadre di cinque, sei o dieci operai, a seconda di quanto lavoro la squadra si sentiva di fare, con alla guida uno della squadra che se ne intendeva di più ed aveva le funzioni da caporale e da cuocitore. Era quella persona che, sentito il parere di qualche altro della squadra, contrattava il prezzo, cioè un lavoro a cottimo; se il bosco era di alto fusto, e le persone esperte che avevano osservato il bosco, avevano valutato bene la situazione, tagliando la legna e riducendola a carbone, forse alla fine dell'inverno ci poteva avanzare qualche mille lire. Ma se invece del bosco di alto fusto, si trattava di dissodare, cioè cavare tutte le radici del sottosuolo, nel nostro gergo dicevamo "cavà le ciòccare", e ridurle sempre a carbone, allora era un'incognita, perché non potevi e sapevi valutare con precisione che cosa ci poteva essere nel sottosuolo, ma sempre poco, perché si trattava di molto lavoro e poco prodotto, facendo una fatica enorme con lo zappone. Ricordo tante di quelle squadre che, dopo aver lavorato tre-quattro mesi senza contributi ed aver mangiato polenta giorno e sera, alla fine per far ritorno a casa dovevano vendere qualcosa della comunità oppure richiedere i soldi a casa. Cosa che successe anche a mio nonno e a mio fratello Pasquale che, dopo aver lavorato per tre mesi nella provincia di Foggia a cavà ciòccare, per far ritorno a casa dovettero venire dove eravamo io e mio fratello Alfonso che pascolavamo le pecore, così il nostro massaro gli diede 2.000 lire del nostro salario per far ritorno a casa. Questo era il lavoro del carbonaio, un lavoro duro, misero, sporco, perché essendo lontano dalla famiglia, ti dovevi lavare qualche volta anche la camicia. Toccava lavorare dieci, dodici ore al giorno, cominciando la mattina molto presto, e terminando la sera all'imbrunire; anzi, la notte quando era scuro, si facevano quei lavori che non richiedevano molta precisione, come la sega dei tronchi degli alberi. Quasi in tutte le squadre c'era un ragazzo, o un giovanotto alle prime armi, che provvedeva a far da mangiare, e a cuocere di notte fagioli e fave, ed a fare la polenta o altri lavori inerenti la custodia della capanna, ed era quella persona che maggiormente passava i guai, perché essendo più piccolo, veniva da tutti comandato, mal nutrito e mal pagato. Qualche volta poteva succedere che qualche squadra composta da elementi giovani poteva fare un buon contratto e guadagnare qualcosa di normale, ma mai si poteva ricompensare una vita di sacrifici così crudeli nel mezzo del bosco. Invece era tutto il contrario dalla parte dei datori di lavoro. Per loro che commerciavano nella vendita della legna e carbone, ed approfittavano anche della disoccupazione e dell'umiltà della povera gente, per loro - dicevo - le cose andavano molto bene, perché tutto si veniva a sapere del ricavato delle grandi partite boschive, anche guardando il tenore di vita delle loro famiglie. Ma non è di questo che volevo parlare, perché sembra che ai giovani di oggi gli suona come un ritornello rievocare le sofferenze del passato, accusandoci di essere stati molto umili, e di non aver preteso i nostri sacrosanti diritti, come avviene oggi. Purtroppo è la verità: è colpa della nostra poca cultura che ci teneva all'oscuro della realtà della vita. Adesso le cose sono cambiate, ed in meglio. Ci sono state nel ventennio precedente tante conquiste sempre migliorative, e così speriamo ancora nell'avvenire, e del passato non possa che rimanere un ricordo lontano. I cavalli di casa Dell'Armi Quando nel 1916 mio padre morì in guerra noi ci ritirammo definitivamente a Capracotta, dato che prima facevamo la spola fra la Puglia e la montagna, cioè l'inverno mio padre e mio nonno andavano a lavorare nella provincia di Foggia, pertanto anche mia madre e noi bambini, che risiedevamo in paese, la primavera ritornavamo nel Molise. Mio nonno Pasquale Dell'Armi, forse con qualche spicciolo che aveva messo da parte o grazie alle prime lire che mia madre riscosse della pensione di guerra, comperò due mucche ed una cavalla col puledro. Mi sembra una visione così lontana, come un'ombra, perché questo avvenne se non sbaglio verso il 1919-20 o qualche anno prima, ed io avevo quattro-cinque anni, quindi molto piccolo per descrivere meglio ogni particolare. Però ricordo con precisione che fu un animale che tenemmo pochi anni e che mio nonno vendette subito. In seguito comperammo un grande e maestoso mulo, forse non adatto alle esigenze della piccola azienda agricola familiare. Passò come un'ombra nella mia mente tanto che, per ricordarmene, ho dovuto compiere uno sforzo di memoria, perché il mulo fece la stessa fine della cavalla, cioè fu rivenduto immediatamente. Finalmente, dopo due esperienze negative, la terza andò molto bene perché comperammo da un compaesano un cavallo giovane di nome Pupitto, dal mantello baio, un cavallo che abbiamo tenuto più di vent'anni. Un cavallo adatto all'azienda familiare, docile, un cavallo di una familiarità incredibile. Nella nostra famiglia come nelle altre del paese, quando vi è un solo animale da soma e la famiglia è numerosa, la bestia deve servire due padroni, essere a disposizione di tutti e fare lavori diversi. E questo è stato l'animale adatto per lunghi venti anni. Tenere un cavallo così a lungo - non so come potrei descrivere la circostanza - ti ci fa affezionare al punto che hai come un chiodo fisso nella mente; pensi sempre a lui, affinché non gli succeda nulla, perché per noi piccoli agricoltori, in quel periodo, un cavallo o una qualsiasi altra bestia, era tutto il nostro avere, era la vita intera. Il primo pensiero del mattino era per le bestie della stalla, oppure per quelle che stavano al pascolo. E l'inverno... quanto lavoro e quante cure per tenerli in buona forma, perché l'estate ci dovevi lavorare! Noi agricoltori dovevamo fare tutto di fretta, visto che a 1.421 metri di altezza l'inverno arriva presto e si protrae a lungo... pare che non passi mai! Sembra che ora la situazione metereologica sia cambiata a tal punto che d'inverno non nevica più come quarant'anni fa. O forse, vivendo da quasi trent'anni a Roma e facendo una vita migliore, non provo più quelle emozioni e quelle preoccupazioni che ora sto raccontando. Nel descrivere dopo molti anni il valore di questo animale così docile, ricordo e ripenso ai suoi infiniti pregi, a quanto fosse movimentata la vita a Capracotta. Era necessario avere un pochino di tempo libero e il cavallo a portata di mano, e potevi correre verso i boschi comunali a recuperare legna per il fuoco. Legna, sempre legna: era un pensiero incessante, perché in quei luoghi il camino non si spegneva mai, nemmeno ad agosto. Ma più di ogni altra cosa, rammento un'altra qualità di quel cavallo. Quando per due-tre anni andammo a lavorare in provincia di Potenza - precisamente a Montemilone - ad oltre 400 chilometri dal mio paese, ci volevano cinque o sei giorni di cammino. Si partiva verso ottobre-novembre per far ritorno ad aprile-maggio. In quelle occasioni il cavallo fu di grande utilità perché erano quelli gli anni dell'ultima guerra mondiale e per mangiare esisteva la carta annonaria, cioè una prescrizione giornaliera pro capite di pane ed altri beni. Ma noi che lavoravamo nei boschi avevamo bisogno di molto più cibo. Col cavallo giravo sempre alla ricerca (e allo scambio) di merce e qualunque cosa mi capitava, la portavo nel bosco per far mangiare i miei compagni che lavoravano ed aspettavano. Un'altra ragione per cui questo cavallo era così familiare sta nel fatto che era stato privato del sesso. A Capracotta quasi tutti i cavalli e i muli passavano sotto le tenaglie di don Peppe Turchetti, il veterinario, e del maniscalco, mastro Gaetano. Loro erano due professionisti del mestiere che non si facevano sfuggire niente. Quando venivano effettuate operazioni del genere, era una giornata di festa per tutti i partecipanti. Specialmente nei paesi del circondario di Capracotta, ove avveniva nei giorni indicati la castrazione di molti muli ed era richiesta molta forza per reggere le bestie, in quel giorno - dicevo - si stava in campagna e si mangiavano prosciutto e salsicce, e si beveva del buon vino. L'animale, privato dei genitali, diventava più docile e adatto per l'azienda agricola familiare. In verità, durante il periodo della mia permanenza a Capracotta, mi sono orientato verso gli animali di sesso maschile. Perché dico questo? Perché ora, meditando sul passato, ho potuto constatare che prima dell'ultima guerra mondiale, ed anche subito dopo, ho tenuto due-tre dei migliori cavalli, sempre maschi, e una sola cavalla - che in seguito descriverò con esattezza - che non ha generato puledri. È così ed è importante. Perché forse non ne avevo i meriti necessari. Voglio dire che per tenere degli animali da riproduzione, bisogna padroneggiare capacità speciali, avere quella pazienza e quei meriti che pochi agricoltori hanno. Specialmente quando la cavalla è gravida, è necessario utilizzare degli accorgimenti delicatissimi, altrimenti la bestia non darà mai figli, anche se ciò dipende pure dalla fertilità dell'animale, dalla razza e da tante altre cose che non impareremo mai. Antonio Dell'Armi (a cura di Francesco Mendozzi)
- Un molisano ha preso gli inglesi per la gola
Londra, luglio. Era inevitabile che, dopo gli spaghetti, i ravioli e il caffè espresso, anche la pizza napoletana conquistasse una posizione ragguardevole nelle preferenze gastronomiche del popolo britannico. Tanto vero che sempre più si vede aumentare a Londra il numero dei locali che offrono alla affezionata clientela la possibilità di gustare un nuovo Italian flavour; un cibo - dicono loro - completo ed insuperabile nella sua dosatura fra i carboidrati contenuti nella farina di grano, le vitamine del pomodoro, il grasso delicato dell'olio di oliva e gli elementi (di cui mi sfugge il nome) che compongono mozzarella e formaggio. Battuti i Francesi L'autorità degli Italiani nel campo alimentare, ha oscurato - incredibile a dirsi - la fama secolare degli chefs francesi; non perché questi ultimi siano da meno dei nostri, ma per la semplicissima ragione che le specialità gastronomiche italiane si rifanno ad una cucina sana e "casareccia" non sofisticata, che più facilmente si adatta ad una produzione su scala quasi industriale per "consumi di massa". La pizza alla napoletana, sotto questo aspetto, finirà forse per superare l'attuale primato degli spaghetti, date le difficoltà che si incontrano per servire questi ultimi come si conviene; senza cioè cadere nell'imperdonabile errore di farli passare di cottura. A questo proposito, merita d'esser raccontata la storia del marinaio italiano Benito Conti, imbarcato sul mercantile tedesco "Kondor" che fino a ieri si trovava ormeggiato nel porto di Topsham. Il povero Benito, unico Italiano in un equipaggio teutonico, per settimane e mesi di navigazione, ogni giorno che il buon Dio mandava in terra, a pranzo, a cena e perfino all'ora del caffelatte, si vedeva metter dinnanzi enormi porzioni di spaghetti che i suoi compagni divoravano golosamente e che a lui, invece, facevano venire il voltastomaco, ridotti com'erano nelle condizioni di una gelatinosa colla da manifesto. Arrivato il "Kondor" a gettare le ancore in un porto britannico, Benito ha compiuto il passo più grave che un marinaio possa decidere in territorio straniero: quello della diserzione. Scappato come un ossesso da quello che ormai considerava il suo purgatorio galleggiante, ha infilato la porta del più vicino ristorante ed ha ordinato una mezza dozzina di uova frittellate, cotte con la pancetta di maiale come si usa in Inghilterra. Ma si era appena accinto ad aggredire quel piatto così gustoso, che già la polizia portuale gli metteva gli artigli addosso chiudendolo, senza troppi complimenti, in guardina. – O torni a bordo della tua nave – gli fu detto – o finirai l'anno qua dentro. – Per favore – rispondeva come un automa l'affamatissimo Benito facendo mostra di non intendere – datemi un altro piatto di uova sfrittellate. Accontentato e sazio, si rifiutava ostinatamente di tornare fra gli incubi degli spaghetti collosi a bordo della nave tedesca. Per cena chiedeva cotolette di agnello con contorno di piselli e soltanto il pomeriggio seguente, satollo di roast-beef e persuaso dalle autorità consolari, decideva di farsi riaccompagnare da due poliziotti a bordo del "Kondor" che è subito salpato alla volta di Copenaghen, lasciando gli Inglesi sbalorditi per il fatto che un Italiano possa talvolta preferire la galera agli spaghetti. Ma, per tornare alla pizza napoletana che ci ha fornito spunto per queste divagazioni, dovremo occuparci di un altro personaggio di sangue italiano che risiede ormai stabilmente qui a Londra e le cui vicende non mancheranno certo di destare interesse a Capracotta suo paese natale ed o ancor più, forse, a Frosinone dove per una ventina d'anni egli ha esercitato la sua arte. Il nome è Sebastiano Di Cesare, la professione: "caciaro", l'uomo che in un laboratorio della Central London, a pochi passi da Tottenham Court Road fabbrica uno degli ingredienti essenziali per la pizza napoletana: una mozzarella, cioè, che nulla ha da invidiare ai prodotti originali dell'Abruzzo e della Ciociaria. Il termine mozzarella, in verità, suona un po' ostico alle orecchie degli Inglesi e forse sarà bene, in seguito, trovare un nome dal suono più internazionale attaccato al suo passaporto italiano, è ormai da tanti anni uno dei più noti esponenti del cinema britannico. Zampi ha qui un fratello proprietario del ristorante "La Romanella" in Wardour Street - la strada delle Case cinematografiche - dove si danno convegno attori e registi e dove, un paio d'anni fa, si cominciarono a servire alla clientela anche pizze alla napoletana condite con un tipo di latticino che lasciava alquanto a desiderare. Insisti oggi e insisti domani, lo Zampi, regista e buongustaio, riuscì a convincere il fratello ad avventurarsi nella impresa di fabbricare in Inghilterra un prodotto che prima d'ora sembrava monopolio tipico di alcune zone dell'Italia Centro-Meridionale. Sebastiano Di Cesare, mentre con larghi movimenti di mestolo pescava latte cagliato da un gran vascone fumante, mi ha rievocato alcune pittoresche frasi di compatimento pronunciate dai suoi compaesani quando comunicò loro che aveva deciso di accettare l'incarico di far mozzarelle e provoloni nientemeno che a Londra. – Ma tu sei matto – gli dicevano fra l'altro – come vuoi che ti riescano in un clima freddo; e come riuscirai a farti capire dagli Inglesi? "O sole mio" L'esperimento ebbe inizio proprio a Frosinone dove fu inviato per aereo da Londra un grosso bidone di latte inglese che venne trasformato in mozzarella rivelandosi eccellente per questo scopo. Pochi giorni più tardi, Sebastiano arrivava alla stazione di Victoria, si iscriveva ad un corso accelerato di lingua inglese e cominciava a manipolare i suoi candidi prodotti nel locale a pianterreno vicino alla Tottenham Court Road dove il sottoscritto lo ha scoperto per caso recandosi a far riparare l'automobile da un meccanico che lavora poche porte più in là. Ora l'attività del "caciaro" di Capracotta non si limita più alla confezione delle classiche mozzarelle; dalle mani di Sebastiano e degli aiutanti che ha chiamato di rinforzo dal paese natio, escono anche provoloni, ricotta, caciotta e "fior di latte" che ribattezzato, quest'ultimo, col nome "Milk Flower Cheese", viene distribuito ai negozi avvolto in una carta sulla quale spiccano i colori dell'Union Jack e tanto di dicitura "Made in England". Chissà che una volta o l'altra questo delicato latticino non finisca per tornare di rimbalzo in Italia ed il nome esotico non lo faccia diventare alla moda con il tè delle cinque. Del resto, in argomenti di questo genere, abbiamo visto anche di peggio. Qui in Inghilterra per esempio si vende, a centinaia di migliaia d'esemplari, un disco inciso da Elvis Presley sotto il titolo "It's now or never", e da cui la voce del cantante americano si sprigiona dolce, appassionata di vibrazioni nostalgiche. Le parole - come purtroppo oggi avviene quasi sempre per le canzoni - lasciano molto a desiderare; ma la musica è quanto di meglio ci si possa attendere da un tune a tempo di fox lento. Il guaio è che, dopo le prime note, uno si accorge che la musica del fortunatissimo "disco novità" gli è nota, anzi molto famigliare, e subito viene identificata come la più famosa delle canzoni napoletane: "O sole mio". Dal Vesuvio all'America, dall'America all'Inghilterra e dall'Inghilterra all'Italia dove a quest'ora sarà senza dubbio ridiventata "popolarissima". Lo stesso - per fare un altro esempio - per le automobili che i nostri carrozzieri vengono a disegnare in Inghilterra e che qui sono vendute con la etichetta reclamistica dell'Italian style, ma che, esportate in Italia, suscitano l'ammirazione degli anglofili per la «sobrietà di linea tipica del buon gusto britannico». Per non parlare delle stoffe "Made in England" e via di seguito. Sta di fatto che, oggi come sempre, resta valido il vecchio proverbio per cui nessuno è profeta in patria. Neppure quel Sebastiano Di Cesare che, in una stradetta londinese, poco distante dalla Tottenham Court Road ingombra di autobus rossi a due piani, plasma provoloni e mozzarelle per i pizzaioli del Regno Unito. Antonio Perrini Fonte: A. Perrini, Un molisano ha preso gli Inglesi per la gola fabbricando in piena City mozzarella fresca, in «Il Tempo», XVIII:192, Roma, 12 luglio 1961.
- La Cappella di S. Maria di Loreto: luogo di culto e grande realtà economica
Il primo documento che cita Capracotta risale al 1040; la Cappella di Santa Maria di Loreto di Capracotta è annotata tra i locati alla Dogana di Foggia nel 1600 ed è il più grande proprietario di Capracotta con 9.500 pecore. La chiesetta, piccola e rozza, fu interamente ricostruita ed ampliata nel 1622 ed è presumibile che sia stata edificata originariamente tra il 1400 e il 1500. La sua posizione non è casuale: infatti da una mappa della fine del 1700 si nota che Capracotta terminava a sud-ovest con la Chiesa di Sant'Antonio di Padova e a nord con San Giovanni; un tratturello collegava Castel del Giudice con Capracotta e terminava a San Giovanni mentre un altro tratturello a sud-ovest collegava Capracotta con il grande tratturo Celano-Foggia. L'altro grande Tratturo Ateleta-Biferno, seguendo per un tratto il fiume Sangro, dopo Sant'Angelo del Pesco, si allontanava da Capracotta per attraversare il Trigno dopo Montefalcone. L'enorme numero di pecore che d'estate pascolava nel territorio di Capracotta per affrontare la transumanza, doveva per tante ragioni imboccare una strada non troppo ripida e con pochi ostacoli naturali e la strada più agevole era per l'appunto il tratturello che partendo da sotto la Madonna, affrontava una graduale discesa sfiorando le pendici di Monte Capraro, aggirando ad ovest Monte Miglio e, attraversando San Pietro Avellana, si congiungeva all'inizio della piana di Staffoli al tratturo Celano-Foggia. La chiesetta della Madonna era dunque l'ultimo contatto dei pastori con Capracotta ed era lì che avveniva il doloroso distacco dagli affetti più cari ed era lì che avveniva il primo contatto al ritorno primaverile. Non ci volle molto per trasformare quel posto in un luogo sacro: chi partiva e chi restava si affidava alla protezione della Madonna di Loreto. La devozione fece sì che le continue offerte trasformarono la Cappella in una grande realtà economica al punto da possedere un cospicuo patrimonio tra terreni, tra cui una vigna a Agnone, oro, animali: nel 1700 registrava ben 21.210 pecore alla Dogana (per inciso, erano quasi 300 le persone addette alla cura di tante pecore). Da un documento del 1819 riguardante il contratto di censuazione delle terre a pascolo si deduce che Postapiana, in massima parte, e poi Bosco da Capo, Bosco da Piedi, Mezzamesa nella locazione di Canosa e Macinati nella locazione di Lesina, erano le zone dove le pecore della Cappella svernavano. Nello stesso anno 1819 la Cappella chiese il permesso di dissodare e coltivare la quinta parte dei terreni censiti in Bosco da Capo di Canosa. Da altri documenti apprendiamo che la Cappella funzionava anche come banca effettuando prestiti; qualcuno doveva pur essere delegato ad amministrare un tale patrimonio ed ecco che in un documento del 1807 è indicato Diego di Ciò come procuratore della Cappella e in un altro del 1819 il canonico Giustino Comegna come amministratore. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio furono devoluti per fini sociali e umanitari; ad esempio nel 1697 la Cappella donò 1.000 ducati (somma enorme per l'epoca) al Comune per acquistare grano per i cittadini; nel 1725 contribuì con 700 ducati alla costruzione del seminario di Trivento; dal 1662 sostenne il Clero di Capracotta formato dal parroco e da sette sacerdoti con una rendita annua di 312,65 ducati; infine nel 1730 impegnò un'ingente somma per ricostruire la Chiesa Madre sui ruderi dell'originaria chiesa. Ma nonostante questi pesanti impegni, nel 1740 contava ancora 9.005 pecore per salire a 17.980 nel 1750, scendere a 4.280 nel 1780. La crisi della transumanza, iniziata agli inizi del 1800, ridimensionò un poco le risorse della Cappella; le leggi eversive del 1866 e del 1867 contribuirono invece alla fine del patrimonio della Cappella che fu trasferito al demanio dello Stato e i fabbricati vennero poi concessi al Comune previa richiesta di utilizzo per pubblica utilità. Interessanti sono le vicende legate alla statua che venne rinvenuta tra il 1400 e il 1500 in località Vallesorda dove aveva sede un monastero benedettino; in seguito fu denominata Santa Maria di Loreto, protettrice dei pastori nella transumanza. In origine la statua aveva sul braccio sinistro un Bambino che faceva corpo unico in un tronco di pero; inspiegabilmente il Bambino venne reciso, sostituito da un braccio e la Madonna venne arricchita da un manto stellato. Il bambino fu rubato il 15 settembre 1981 e da allora non più ritrovato. Il 7 settembre 1978 la chiesetta venne elevata al rango di Santuario. Nei primi giorni di settembre, a seconda delle condizioni climatiche, le partite di pecore che avevano trascorso l'estate nella nostra zona riprendevano la strada verso il Tavoliere e gradatamente l'avvenimento assunse la dimensione sacra con messe solenni e benedizioni ai partenti; con il passare del tempo l'inizio della transumanza si trasformò in una vera e propria ricorrenza religiosa con un novenario di preparazione, con l'uscita della Madonna dalla chiesetta, accompagnata dai cavalli addobbati, per il ritorno originario alla Chiesa Madre, poi la processione per le strade di Capracotta e infine il rientro alla chiesetta. Non sappiamo quando questo ciclo si sia trasformato in triennale ma è logico supporre che, dopo la crisi della transumanza e l'inevitabile emigrazione, avesse più senso consolidare la tradizione con una grande festa triennale per consentire più agevolmente ai capracottesi sparsi in Italia e nel mondo di essere presenti all'appuntamento sacro con la protettrice di quegli addetti alla transumanza, antenati di quasi tutti i capracottesi di oggi. Domenico Di Nucci Fonte: D. Di Nucci, La Cappella di S. Maria di Loreto: luogo di culto e grande realtà economica, in «Voria», II:4, Capracotta, settembre 2008.
- L'origine di Capracotta
Nei folti boschi che coprivano gli alti monti che circondano Capracotta, molti pastori solevano portare i loro animali al pascolo. Giravano continuamente, d'estate e d'inverno, senza mai fermarsi. Stanchi di questa vita, un giorno decisero di porre la loro stabile dimora al di sotto di quei monti. E così fecero. Ogni famiglia costruì la sua casetta e a poco a poco sorse un villaggio, naturalmente un villaggio piccolo, con poche case e poca gente. I pastori erano contenti di essere pochi, perché questo dava loro una maggiore tranquillità. Alla borgata ora bisognava dare un nome. Quale? I pastori si riunivano ogni sera, nello spiazzale davanti alle case, per discutere sul nome da dare al villaggio ma ogni volta si lasciavano senza aver deciso nulla. L'aria era rigida e per attenuarne i rigori accendevano un fuoco attorno al quale poi si attardavano a discutere. Pensavano ad un nome che si riferisse ai boschi, alla rigidezza del clima, ai monti alti, ma ogni volta che credevano di aver trovato, ricominciavano da capo. Passavano intanto i mesi, senza che riuscissero a trovare per il loro paese un nome che lasciasse tutti soddisfatti. Ormai il piccolo villaggio sembrava destinato a rimanere senza nome quando una sera, da un angolo, sbucò improvvisamente una capra; essa si fece largo tra i pastori incuriositi, si fermò davanti al fuoco, spiccò un salto e cadde nel fuoco, poi con un balzo improvviso ne uscì fuori e si allontanò lentamente dalla parte opposta da cui era venuta. I pastori la seguirono con lo sguardo fino a quando disparve ai loro occhi. Cercarono di rintracciarla, ma ogni loro ricerca fu vana. La capra non c'era in nessun luogo. Ritornarono attorno al fuoco e cercarono di interpretare l'accaduto. Era chiaro che si trattava di un segno divino. Uno dei pastori, quello che più si era opposto ai nomi trovati dai loro compagni, propose allora di chiamare il paese Capracotta. Questa volta non ci furono discussioni né opposizioni. La proposta fu accettata da tutti e così il nome fu trovato. Lo stemma del Comune ne ricorda il modo: una capra che salta sul fuoco. Il 16 giugno i capracottesi si recano fuori del loro paese, per rivivere il clima di pace e tranquillità di quei tempi lontani e ripetono la scena della capra che salta sul fuoco, da cui ancora credono che abbia avuto origine il nome con cui è stato indicato il loro paese. Renato Lalli Fonte: R. Lalli, Il Molise tra storia e leggenda, Casa Molisana del Libro, Campobasso 1966.
- I figli miei e i figli tuoi
La storia che mi accingo a raccontarVi - i discendenti lo giurano - è vera, talmente vera da aver dato vita a un mantra, a una di quelle freddure che a Capracotta vengono ricacciate quando la situazione lo permette. I protagonisti di questo esilarante racconto sono Giovanni Di Luozzo e Teresa Carnevale, detta Senèlla, sposatisi in seconde nozze nel 1934. Il fatto è che entrambi, prima di convolare a nozze, erano già stati sposati ma, dopo aver avuto figli, avevano purtroppo perduto i rispettivi coniugi. Giovanni aveva infatti tre ragazzi, Luigi, Paolo e Maria (Mariétta), quando sposò Teresa. Teresa aveva invece due figli, Edmondo (Mondìne) e Giovanni (Papacchétta), quando sposò il suo di Giovanni. La loro casa, piuttosto gremita, diventò ancor più affollata quando i coniugi Di Luozzo misero al mondo altri due figli, Lucia (detta Ciétta) ed Antonio, nati dalla loro unione e per questo fratellastri dei cinque ragazzi avuti nei precedenti matrimoni. Per i vedovi, sia maschi che femmine, risposarsi era innanzitutto una necessità. Gli uomini che non avevano più la moglie non potevano badare alla prole perché spesso facevano lavori pesanti che li tenevano lontani dall'alba al tramonto. Le donne che avevano perduto il marito, d'altronde, non avevano più una fonte di reddito sicura e quindi un secondo matrimonio era quasi obbligatorio se non volevano rischiare di morir di fame con tutta la figliolanza. Giovanni e Teresa abitavano nel rione S. Antonio, su via S. Maria di Loreto, in una casa dignitosa e antica, esattamente dietro all'odierna stazione di servizio di Mario Di Lullo (Cannóne). Gli anni passavano e nell'ingarbugliata ma allegra famiglia Di Luozzo non mancavano, come in tutte le case, le baruffe, dovute soprattutto alla normale escandescenza dei sette giovani fratellastri. Un bel giorno Teresa sentì delle urla giungere dal retro e, non appena si affacciò alla finestra per vedere cosa stesse accadendo, vide una schiera di ragazzi accapigliarsi con furia, e strepiti e imprecazioni e botte da orbi. Teresa capì subito chi erano i rissosi. Vide Edmondo litigare con Paolo, Lucia che sbraitava contro Maria, Luigi bisticciare con Giovanni e, rivolta a suo marito che proprio allora stava rientrando a casa, gridò: – Giuvà, re figlie mié e re figlie tié ŝtieàne menànne re figlie nuóŝtre! (Giova', i figli miei e i figli tuoi stanno picchiando i figli nostri!). Francesco Mendozzi
- Sfrattata
Ah, che pacchia oggi. Casa, calduccio, relax. Che voi de più? Certo c'ho mpo' de fame, me sa che s'è fatta 'na certa. In frigo un cazzo, come al solito. Famme anna' a bussa' 'n attimo a quella che abita de sopra, magari se famo du spaghi. Bom. Oh? C'è nessuno? Bom. Ehilà? Che famo? Non se magna oggi? Vabbè che stai a dieta cì, ma almeno a me famme magnà, dai! Bom. Nun erano questi i patti, bella mia. Bom. Cor cibo non se scherza. Bom. Apri 'sta cazzo de porta! Bom. Bom. Bom. Ecco, già me sento sveni'. Me cedono le gambe. C'ho 'sta strana sensazion… Oddio chi siete, 'ndo me portate, fermi. So innocente. No, ve lo giuro, volevo solo magna', non volevo da' fastidio. Maledetta bastarda, hai chiamato le guardie! Appena esco te rovino! Te vengo a cerca'! Te arzo un macello che er Fight Club è 'na scampagnata a Capracotta ar confronto! E tu chi sei? Che voi? Nun me tocca'. Senti bello, a me non me ne frega un cazzo, io ce metto niente a rivoltatte come 'n pedalino. Ecco, mo chi è questa? Che c'hai da guarda’? Ah, sei tu. No senti, io te volevo di' che me dispiace pe' tutta 'sta caciara oggi. Cioè, lo so che siamo partite col piede sbagliato, ma stavo a mori' de fame. Non è successo niente, 'o so che non volevi chiama' tutto 'sto A-team de rincoglioniti. Dai, mo non piagne. Abbracciamose. Basta così, niente più rancore. Ecco vedi, t'ho fatto sorride. Certo nun è male qua fuori. Me devo un attima abitua' a tutta 'sta storia degli altri, del mondo, de 'sta luce. Ecco sì, la luce. È 'na cosa strana dopo nove mesi de buio. Ma devo di' che te dona, te fa più bella. Oh e comunque, non se semo presentate. Ciao ma', piacere. Sonia Ceriola Fonte: S. Ceriola e U. Race, Recensire con pressappochismo. Film, università, tendenze e altre storie buttate là..., Bibliotheka, Roma 2017.
- Cronachette di Capracotta
Capracotta, 20 luglio. Finalmente è sbocciata, gioiosa e briosa, la Primavera. Era ora. Questa invasione nella nostra graziosa cittadina di "papaveri" e di "garofani rossi" ha sorpreso un po' tutti i suoi gravi e bravi montanari perché ci eravamo in verità rassegnati a toccare il prossimo inverno senza alcuna pausa primaverile o estiva tanto il tempo quest'anno ci ha tradito. Quanti papaveri, quanti garofani rossi in Capracotta! Tanti, tanti, tanti... Abbiamo pertanto avuto occasione di conoscere il deputato comunista onorevole Amiconi, presentato dall'amico Giulietto Tedeschi, da quel Giulietto Tedeschi ormai noto come l'acqua santa dei comunisti molisani, un'acqua santa con i baffi, anzi con i baffoni perché Tedeschi d'Isernia oltre che per acqua santa è rinomato per i suoi baffi ormai in contrasto (i baffi) con i più avanzati principi suoi (dell'amico d'Isernia). Ma tant'è... Che ci possiamo fare se il nostro Giulietto, essendo ancora un uomo libero, liberamente si porta e si comporta? La cronaca a un certo punto dice: poi la comitiva con in testa il sempre sorridente Amiconi, si mosse per Prato Gentile per consumarvi la prevista colazione. Anche questa fu consumata con ordine e disciplina. Lucio Venditti, Pasqualino Mendozzi, Ugo Ianiro e Antonio Policella non sono solo dei classici del tresette, delle pallette, delle scope e degli scoponi più o meno scientifici, del turismo di varia classe o di altre cose del genere, ma sono anche dei rinomati sportivi trasportatori di mobili. Ma, a onore del vero, bisogna precisare che questo sport faticoso esercitano volentieri, solo però in conto e a carico di amici disposti a pagare una cenetta. Questa volta la vittima, vale a dire l'amico disposto a pagare la cenetta, è il... sottoscritto, che in verità ancora salda il debito perché ha sempre una strana sensazione di insolito brivido al semplice pensiero dei sopracitati quattro classici forchettoni. Faranno i bravi? Mah... Staremo a vedere. La fiera e la festa in onore di san Sebastiano si sono svolte secondo il prestabilito programma e con larga partecipazione di forestieri. Peccato però che il cattivo tempo abbia dovuto disturbare sia la fiera che le manifestazioni in programma. Gustavo Conti da Capracotta ci ha pregato di precisare, in risposta a Peppino Ruggieri, il noto Gierre, che per lui (per Gustavo), vi è una bella differenza fra l'arte pura e quella impura, fra il sacro e il profano, fra la danza classica o folkloristica o tradizionale e le gambe più o meno perfette, i promotori più o meno audaci, le insenature più o meno nascoste dalle donnine più o meno belle che alle sopradette danze muovono con disinvoltura i loro piedini più o meno agili, più o meno profumati. Egli (Gustavo) è senz'altro per l'arte pura, per il sacro, per la danza classica o folkloristica o tradizionale come tale. Così fu in verità a Montedimezzo. Possiamo dire altrettanto di Peppino Ruggieri da Pescolanciano? È pure egli per parte pura, per il sacro, per la danza come tale? O non più tosto per l'incontrario? Estate di San Martino Questa bella "vista" del fotoreporter Colli è stata presa in questi giorni di desiderata estate di San Martino dalla Villa Comunale di Capracotta, recentemente ripulita e definitivamente sistemata. La "vista" è veramente interessante: lontano le Mainarde già in abiti invernali; più in qua la montagna (a forma di triangolo) di Roccaraso; giù il Sangro e la sua valle pittoresca nascosta di fitta nebbia. Sembra, a vedere questa fotografia, che abbia ragione quel nostro amico capracottese quando afferma che noi quassù siamo più vicini al cielo che alla terra... Durante Antonarelli Fonte: D. Antonarelli, Cronachette di Capracotta, in «Momento-Sera», VIII:172, Roma, 21 luglio 1953.
- Lucia
Lucia era una strana creatura: gli occhi spiritati, il capo scosso da un tremito su un corpo nodoso e robusto, la voce alterata che sembrava uscire più dalle sue vesti grigie e logore che dalla bocca, i capelli scarmigliati. Veniva dal paese diretta al bosco e di ritorno da questo, passava cantando, recitando, fermandosi di tanto in tanto a rispondere alle donne, blaterando chissà cosa ai ragazzini incuriositi e spaventati insieme. Saliva la strada lentamente e spariva inghiottita dalle rocce come fosse parte di loro dietro la curva del pilone. Ricompariva nel tardo pomeriggio più scompigliata con una fascina di céppe sul capo, oppure con una manciata di gallucci e di fragole nelle tasche, un bottino semplice che la faceva strega e fata allo stesso tempo. Lei aveva il fascino delle fiabe, di chi conosce la natura con la quale sa dialogare meglio che con le persone: il suo vivere quel solitario rapporto con il bosco, in cui si aggirava confondendosi perché già elemento silvano, era un mistero. Tra le case stonava: in occasione di una festa religiosa, durante i canti e i fuochi d'artificio le sue note accresciute e scomposte portavano la folla al riso e alla pena, ma lei continuava in un'enfasi sproporzionata di risposta a chi la voleva ridurre al silenzio. Abitava in paese in una casuccia addossata alle altre, nei pressi della mastodontica e rassicurante Chiesa Madre, tra quelle mura modeste viveva con una sorella la sua vita straordinaria. Flora Di Rienzo Fonte: F. Di Rienzo, Piccolo florilegio, Capracotta 2011.
- Signorina Allergia
Che cosa vi devo dire che non vi abbia già detto. La verità? Ah, certo, la verità. Finalmente la verità. È che bisognerebbe intenderci sul significato che diamo alla parola: Edoardo, se fosse al mio posto, pretenderebbe senz'altro di discuterne, perché ha studiato filosofia, lui. Personalmente, credo che la verità sia una cosa che comincia quando siamo piccoli, giusto? Almeno su questo possiamo essere tutti d'accordo, perfino Edoardo (anche se lì per lì si ostinerebbe a sostenere di no, ma solo per partito preso, lui è fatto così, è contro a prescindere). Allora: quand'ero piccola. Quand'ero piccola a casa mia eravamo in tantissimi. Almeno otto, eravamo. Spesso nove, quando la tabaccaia bionda ossigenata trovava uno spazio fra un fidanzato nuovo e l'altro. Mio fratello e io dormivamo in una stanza. Nell'altra c'erano mio padre, la Lella, Giuditta, la tabaccaia bionda ossigenata se le girava, mia madre e nonno Marcello. E poi c'era Polly. Io davo moltissimi problemi ai miei genitori. Se ridevo troppo mi prendeva un attacco d'asma, se piangevo mi prendevano i crampi allo stomaco, se a scuola giravano i pidocchi o il morbillo, per la mia testa correvano inevitabilmente più pidocchi rispetto a quella degli altri bambini, sulla mia pelle più bollicine. Se faceva troppo caldo mi riempivo di chiazze fucsia, se faceva troppo freddo una stretta mi afferrava subito i bronchi. Ma, soprattutto, ero allergica a tutto: alla polvere, al latte, al polline, alle graminacee, al pelo dei cani, al fumo delle sigarette, al pomodoro. – Ma questa non è una bambina, è un'epidemia! – Diceva senza dire niente mio padre a mia madre. – Ci credo, è figlia tua. – Ribatteva senza ribattere niente mia madre a mio padre. Mio fratello, al contrario, non dava problemi a nessuno. Si chiama Teodoro, è morto che aveva due anni. Dopo dieci mesi sono nata io, inutilmente: nel senso che mia mamma avrebbe continuato a comportarsi come se avesse solo un figlio di cui andare orgogliosa e per cui avesse davvero senso preoccuparsi. Lo dico senza astio, credetemi: io per prima ho sempre avuto un debole per lui, rispetto a me. Mi faceva innervosire a volte, lo ammetto. Ma tra fratelli capita, no? Dormivamo insieme, ve l'ho detto. Quando la mamma veniva a svegliarci per andare a scuola, era per lui, io lo sapevo benissimo, che bussava prima piano e poi forte alla porta della nostra camera, per lui che spremeva le arance, tostava il pane e si sforzava di sorridere, prima che uscissimo di casa. Avete presente un gatto, se sapesse lamentarsi? Così era mia mamma. Con gli occhi lunghi, color birra, i movimenti veloci, felpati. Da gatto, appunto, come se quella in cui si muoveva, da cui usciva solo per fare la spesa, fosse casualmente casa sua. E aveva questo impellente bisogno di comunicare agli altri quello che le mancava. Cioè tutto. Capracotta, il paese vicino a Isernia dove lei e mio padre erano nati, cresciuti e vissuti, prima che mio padre fosse trasferito a Roma dalla ditta di confetti per cui lavorava. – Bastava aprire la finestre, guardare le montagne e il mondo pareva bello! Il mare, anche se non l’aveva mai visto. – Ci fosse almeno una spiaggia in questo schifo di città, dove potersi ogni tanto distendere e poi fare un tuffo. I soldi. – Per che cosa ci siamo dovuti trasferire? Per settantamila lire in più al mese. Che tanto tuo padre usa tutti per le sue puttane. Un lavoro. – Mica ero scema io, da ragazza. In matematica ero davvero brava, sai. Ma all'ultimo anno di superiori ho conosciuto tuo padre e sono finiti i sogni. È cominciata la vita, se si può chiamare così questa che m'è toccata. Un uomo. Che però non fosse mio padre. – Basta, basta! Basta! – Soffiava, quando perfino di lamentarsi non ne poteva più. E si chiudeva in camera sua. Cioè loro. Ma non ci si chiudeva con mio padre, ci si chiudeva con il suo, di padre. Nonno Marcello, insomma. Io non l'ho mai conosciuto, perché aveva abbandonato mia nonna quando mia madre aveva quindici anni. Un bel giorno era partito per Pescara, per una fiera di artigianato, e semplicemente non era tornato più. Qualche mese dopo avrebbe spedito una lettera con diecimila lire, avrebbe lasciato la falegnameria a mia madre e ai suoi fratelli, avrebbe scritto che gli dispiaceva tanto, ma una certa Hilda a Berlino aspettava il terzo figlio da lui: gli sembrava arrivato il momento di prendersi le sue responsabilità, e sarebbe sparito per sempre. Ma la colpa, a sentire la mamma, era stata tutta della nonna. – Gli rovinava l'esistenza, poveraccio. Lui era un'anima bella. Un uomo sensibile. Mica come quel puttaniere di tuo padre… Ti ho mai raccontato di quando ci ha portato tutti a fare un pic-nic ad Agnone, il paese delle campane? Una domenica ha caricato sul furgoncino me, mia madre, i miei fratelli e… Me l'aveva raccontato mille e mille volte: ma la lasciavo sempre fare, perché erano gli unici momenti in cui gli occhi da gatto le scintillavano, anziché allagarsi di rimpianto o di nostalgia. Finché a una certa ora della sera tornava a casa papà, grandioso di cattivo umore e stanco. E ci sedevamo a tavola. Noi tre e tutte le altre presenze. – Se tu non fossi la bestia traditrice che sei. – Gli diceva senza dire niente mia madre, mentre gli riempiva il piatto. – Se tu fossi l'uomo che non sei… – Se tu ridessi come ride la Lella, quella donna giovane e strana che viene da Milano, dipinge tramonti e abita al terzo piano. – La interrompeva e le rispondeva senza risponderle niente mio padre, mentre masticava. – Se tu avessi un grammo della mitezza di Giuditta, la mia vicina di scrivania. Se avessi almeno i capelli biondi e la smania di essere bella della tabaccaia qui sotto. – ...forse Teodoro non sarebbe morto. Perché se tu fossi l'uomo che non sei, quella notte in macchina avresti corso di più e saremmo arrivati in tempo all'ospedale. – Aggiungeva lei, senza aggiungere niente. – Non sarebbe morto perché avrebbe ereditato un po' di attaccamento alla vita, se tu fossi la Lella o Giuditta o la tabaccaia qui sotto. – Aggiungeva lui, senza aggiungere niente. Tantissimi, ve lo ripeto: eravamo in tantissimi. Finito di cenare ci sistemavamo tutti sul divano, a guardare la televisione. La Lella si appollaiava su un ginocchio di papà, Giuditta sull'altro e ogni tanto si giravano e lo accarezzavano con lo stesso sguardo che gli lanciavano quando lo incontravano ma lui era con me, ed erano costrette a dirgli tutto solamente con gli occhi. Io mi accomodavo in mezzo, fra mio padre e nonno Marcello: mia madre in braccio a lui e in braccio a lei mio fratello Teodoro. La tabaccaia si aggrappava al lampadario e si lasciava dondolare, svogliata e civetta come quando allungava le sigarette a mio padre. Polly preferiva aspettarmi in camera e studiare i suoi spartiti. Oltre alla musica, e oltre a Tom naturalmente, voleva bene solo a me: era la mia amica più cara, a dirla tutta l'unica. Con le mie compagne di classe non mi trovavo proprio, sapete, non mi veniva da ascoltare quando parlavano, non mi veniva da parlare quando avrebbero potuto ascoltarmi. Polly era esattamente come me: Una ragazza fuori moda. Quel libro me l'aveva regalato proprio Giuditta, la collega di papà, per il mio ottavo compleanno. Fino a quel momento non mi era mai piaciuto leggere, lo facevo come facevo il resto delle cose, più che altro per non creare ulteriori problemi rispetto a quelli che già creavano le mie allergie e per non sfigurare ancora di più rispetto a mio fratello. Ma fin dalle prime due pagine di "Una ragazza fuori moda" Polly con i suoi vestiti sempre sbagliati, con le sue parole inopportune, con quel vizio di sentire con il suo cuore e pensare con la sua testa, mi aveva conquistata. Così era con lei che, prima di addormentarmi, mi confidavo. Solo a lei avevo raccontato di avere visto una mattina, in garage, la Lella e mio padre fare quelle cose. Solo con lei avevo il coraggio di sfogarmi, di dire chiaro e tondo che secondo me a volte Teodoro esagerava e si approfittava di essere morto o che almeno Giuditta era simpatica, Lella era giovane, ma la tabaccaia puzzava di grappa anche alle otto di mattina e insomma, che cosa ci trovasse mio padre era davvero un rebus impossibile. Solo a lei potevo rivelare che quando un batuffolo di polline mi danzava attorno o, al refettorio della scuola, la cuoca si distraeva e non mi preparava a parte un piatto di pasta senza parmigiano, o quando, all'improvviso, qualcosa di inaspettato, rosso morbido duro giallo o cremoso che fosse, arrivava all'improvviso da fuori e crash, impattava dentro di me e io cominciavo a tossire e a riempirmi di macchie: beh. Tutti ormai erano sereni, tutt'al più scocciati ma comunque certi che l'attacco sarebbe passato, che sarebbe bastata una pillola delle mie o magari un'iniezione e in poche ore la tosse si sarebbe sciolta, le macchie si sarebbero scolorite. Ma a me ogni volta pareva di morire. Proprio di morire, mi pareva: e questo solo a Polly riuscivo a dirlo. Nemmeno a me, solo a lei. È stata per me più importante di una coscienza, più cara di una sorella e non smetterò mai di esserle grata. Poi, è arrivato Edoardo. Dal giorno in cui l'ho conosciuto ho smesso di trascorrere tutto quel tempo con Polly, ma lei ha senza dubbio capito. Lei lo sa, che cosa significa innamorarsi. Le è bastato incontrare Tom quel giorno, in stazione, per non cavarselo mai più dal cuore: e anche se lui ci ha impiegato davvero tanto per trovare il coraggio di dichiararsi, i fatti alla fine hanno dato ragione a lei. A tutto quello che subito ha sentito. Anche con Edoardo è successo così: subito e tutto e in una stazione. In me sto bene / come il mare in un bicchiere / ma se sono confinata in questo calice / qualcuno mi può bere: li ha scritti lui questi versi. Li ha scritti per me, o almeno così mi ha detto. Perché era un bugiardo per sua stessa ammissione - un bugiardo buono, però, ne sono convinta, e se l'aveste guardato negli occhi ne sareste convinti anche voi. Erano verde triste, i suoi occhi, con un segreto dentro. L'ho conosciuto d'estate, subito dopo la maturità. Finiti gli esami, come al solito mio fratello, nonno Marcello e io stavamo accompagnando mia madre a Capracotta e come al solito mio padre (naturalmente con la Lella, Giuditta e forse la tabaccaia al seguito) ci avrebbe raggiunti per la settimana di ferragosto. Siamo saliti sul treno e c'era questo ragazzo strano, nel nostro scompartimento. Mia madre si è presto addormentata, mio fratello, eternamente in braccio a lei come un marsupio, anche, nonno Marcello mi pare si fosse alzato per andare al bagno, non ricordo. Perché all'improvviso c'era solo lui. – Non bisognerebbe mai dimenticarsi dei cipressi, sei d'accordo? – Ha detto, mentre Roma e i suoi alberi correvano fuori dal finestrino, fermi. E quello, ormai posso dirvelo con esattezza - eccola: la verità - è stato il momento più bello di tutta la mia vita. Gli ho risposto che sinceramente non ci avevo mai pensato ai cipressi e che se appartenevano alla famiglia delle graminacee, io purtroppo alle graminacee ero allergica, ma in ogni caso mi sarei sforzata per non dimenticarmi di loro, se la questione era tanto importante. E lui mi ha detto sei buffa. Gli ho chiesto in che senso? Buffa, ha ripetuto lui. Ho riso, come faceva Polly all'inizio del libro, quando Tom la prendeva in giro e la chiamava cafona, ma solo per prendere tempo, perché non sapeva ancora chiamarla amore mio. Ha riso. Gli ho chiesto come ti chiami? Ha risposto Edoardo. Gli ho chiesto dove vai? Ha risposto a Isernia. Gli ho chiesto hai fatto anche tu la maturità? Ha risposto no, studio filosofia. Gli ho chiesto ti piace? Ha risposto molto, mi costringe a tenere la testa aperta, mi permette di raccontarmi un sacco di bugie e di essere a prescindere contro, perché io sono fatto esattamente così, bugiardo e contro a prescindere sono, vuoi una caramella? Mi ha allungato il pacchetto. Gli ho chiesto sono al latte? Ha risposto sì. Ho detto purtroppo sono allergica. Anche al latte? Anche al latte. È allora che ha tirato fuori dallo zaino un quaderno, dove aveva scritto quei versi. E ha detto evidentemente li ho scritti per te stamattina, anche se non ti conoscevo ancora. In me sto bene / come il mare in un bicchiere / ma se sono confinata in questo calice / qualcuno mi può bere: ha declamato. Mi sono emozionata, ho cominciato a tossire. Mia madre e mio fratello si sono svegliati, nonno Marcello è tornato nello scompartimento. Edoardo ha ripreso a guardare fuori dal finestrino. Io continuavo a tossire e a emozionarmi, a emozionarmi e a tossire. Finché il treno è arrivato alla stazione di Isernia. Lui ha detto ciao, signorina Allergia. Io ho detto ciao. Lui è sceso dal treno. Noi no. Il treno è ripartito. Quella stessa estate, avrei dato il mio primo bacio. A diciannove anni? A diciannove anni, sì. Lo so che è tardi, ma se ogni cosa che tocchi rischia di mandarti all'altro mondo, è ovvio che se si passa dalle cose alle persone ci vuole ancora più cautela, no? Infatti quella prima volta non è che sia andata benissimo. Era un mio lontano cugino, lo conoscevo da sempre. Ha mangiato un gelato, io un ghiacciolo, abbiamo passeggiato per il corso, su e giù, e sotto al portone di casa mi ha baciato: sarà stato il latte, perché sul suo gelato c'era una montagna di panna? O ero allergica pure alla saliva di mio cugino? Fatto sta che ho vomitato. Volevo almeno salutarlo e poi salire in casa, correre al bagno: ma non sono riuscita a trattenermi, gli ho vomitato sulle scarpe. Che vergogna. Non ci potevo fare niente: e non solo per l'allergia, sapete. Con quella ormai erano quasi vent'anni che facevo i conti. L'amore per Edoardo, invece, mi lasciava senza difese. A lui avevo pensato per tutto il tempo della passeggiata, a lui avevo pensato mentre mio cugino mi infilava le mani fra i capelli e avvicinava il viso, a lui pensavo sempre, dal momento in cui era sceso dal treno. – Signorina Allergia! – avevo sentito la sua voce prendermi in giro, mentre vomitavo davanti al portone. – Signorina Allergia! – Sempre con il tono scherzoso che aveva sul treno e che aveva Tom quando diceva cafona a Polly ma solo per prendere tempo, perché non sapeva ancora chiamarla amore mio. Tanto che l'allergia, quell'estate, mi è sembrata misteriosamente qualcosa che mi venisse in aiuto, anziché essere un ostacolo, perché, senza passare da maleducata: – Perdonami, non mi sento bene. – potevo rispondere a mio cugino, quando mi chiedeva di uscire. Mentre Edoardo si era definitivamente trasferito da noi, prima a Capracotta e poi, finite le vacanze, a Roma, con mia madre, mio padre e tutti gli altri. Mi sono iscritta all'università, avrei voluto fare filosofia anch'io, ma mio padre me l'ha proibito: ci mancava solo una figlia disoccupata oltre che sempre acciaccata, ha detto. Così ho dovuto scegliere Economia, e nel frattempo ho cominciato a lavorare nella ditta di confetti per tre ore al giorno, come segretaria. Ho scoperto che in ufficio mio padre e Giuditta erano considerati una coppia a tutti gli effetti: e mentre fino a poco tempo prima ne avrei parlato con Polly, adesso che avevo un fidanzato potevo parlarne con lui. Edoardo aveva davvero la testa aperta, grazie agli studi che faceva, e la sua intelligenza mi confortava molto. Ogni notte, per prendere sonno, ripetevo allo sfinimento quei versi: in me sto bene / come il mare in un bicchiere / ma se sono confinata in questo calice / qualcuno mi può bere. E mi addormentavo felice. In ufficio un paio di ragazzi mi corteggiavano: una sera sono andata a cena con uno e un'altra sera con l'altro. Ma il primo parlava troppo e con una foga inutile, il secondo aveva le mani sudatissime. E comunque in entrambi i casi era finita come con mio cugino, devo avere mangiato qualcosa di sbagliato, l'allergia ha deciso per me e mi sono ritrovata a vomitare - una volta appena fuori dal ristorante, l'altra nell'ascensore del tipo. L'unica storia che è durata almeno qualche mese, prima di quella con Giacomo, è stata con Antonio. Mia madre da qualche mese aveva finalmente cominciato a uscire di casa non solo per fare la spesa e si era messa a frequentare un gruppo di preghiera nella parrocchia del quartiere. Mio fratello e nonno Marcello naturalmente andavano con lei e una sera ha convinto anche me a seguirli. Lì ho incontrato Antonio: era gentile, timido, per tutto il tempo passato insieme si è spinto solo a stringermi la mano, una sera, al cinema. Perché aveva ben altro a cui pensare: e mentre lui pensava a Dio, io ero libera di pensare a Edoardo. In piena armonia. Quando ha deciso di prendere i voti, sono stata contenta. Davvero, non ho avuto nessuna malinconia: era la sua strada, non si era mai sforzato per nasconderlo, come io non mi ero mai sforzata di nascondere che la mia fosse con Edoardo. Non avevo idea se, quando, come e dove avrei potuto vederlo: e per Antonio, con Dio, valeva lo stesso discorso. Proprio per questo non abbiamo mai avuto bisogno di spiegazioni, fra noi è stato sempre tutto chiaro, anche e forse principalmente quando è finita. Se il gruppo di preghiera per lui era stato quindi decisivo, con mia madre invece alla lunga non aveva funzionato. Forse sperava che Dio facesse sparire di colpo la Lella, Giuditta e la tabaccaia: mentre quelle, imperterrite, continuavano a rimanersene fra noi, in cucina, in salotto, sul lampadario, fra gli spazzolini, il basilico. Anche quando Giuditta è morta, mica se ne è andata. Anzi: se è possibile, i primi tempi, faceva sentire ancora più forte la sua presenza. – Mia madre amava tuo padre come non ha mai amato il mio e forse neppure me. – Così, al funerale di Giuditta, mi si è presentato Giacomo, suo figlio. Si era laureato da poco in Medicina, sognava di diventare un chirurgo e amava la musica classica, proprio come Polly. Con lei, però, non ero mai andata a un concerto: con Giacomo sì. Mi ha telefonato qualche giorno dopo il funerale di Giuditta per invitarmi ad accompagnarlo a sentire un pianista francese che suonava a Santa Cecilia. Ho detto va bene, più che altro per il senso di colpa di avere sempre sua madre per casa, appiccicata a mio padre, quando forse, soprattutto adesso che era morta, avrebbe voluto averla lui con sé. È stata una serata piacevole? La verità? Forse sì. Anzi, sicuramente sì. Abbiamo scoperto di avere parecchie cose in comune, l'entusiasmo con cui ascoltava il pianista francese mi ricordava il mio, mentre leggevo "Una ragazza fuori moda", era spiritoso, attento, mai banale. E quando, sotto al portone di casa mia, mi ha sfiorato le labbra con le labbra, non è arrivato a mettermi in salvo o in pericolo nessun conato di vomito. Abbiamo cominciato a telefonarci, parlavamo molto. Di sua madre, della mia, di suo padre, del mio, di tutto, di musica, di niente. Alla lunga non ero riuscita a portare avanti per bene sia l'università che il lavoro, ero parecchio indietro con gli esami e lui si è messo a disposizione per aiutarmi. Ogni sabato mattina lo raggiungevo nella mansarda dove abitava con un compagno di specializzazione, e mi dava una mano. Poi pranzavamo tutti insieme: lui, l’altro specializzando e io. Tre e basta, come saremmo stati con mia madre e mio padre, se le altre presenze ci avessero lasciati soli per un istante. Inizialmente Edoardo mi accompagnava, certo: ma dopo un po' ha preferito aspettarmi a casa, perché a studiare le mie cose si annoiava e Giacomo cominciava a non essergli troppo simpatico. Lo trovava, di fondo, un po' invadente: e in effetti lo era. Mi telefonava anche solo per darmi il buongiorno, mi aiutava con gli esami, si premurava di prepararmi da mangiare stando molto attento a evitare gli alimenti a cui ero allergica. – Sei sicura che non siano di carattere puramente nervoso, le tue intolleranze? – Mi chiedeva spesso. E mi proponeva di farmi visitare da un suo amico, uno davvero bravo: – Però quando te la sentirai. Non voglio minimamente forzare i tempi. Eppure, proprio mentre diceva così, secondo Edoardo non solo forzava i tempi: ma soprattutto gli spazi. Più Giacomo si mostrava comprensivo e complice, meno permetteva a me e a Edoardo di starcene in pace da soli. Quando tornavo a casa, Giacomo, se non mi telefonava, s'infilava in un disco che ascoltavo, nel programma tv che guardavo in televisione con i miei genitori e gli altri, perfino nei versi (in me sto bene / come il mare…) che mi ripetevo per prendere sonno. Per un paio di mesi avevo fatto finta di niente: è solo di passaggio nelle nostre vite, se ne andrà e torneremo a stare tranquilli, promettevo a Edoardo. Ma presto era stato chiaro che Giacomo non aveva nessuna intenzione di andarsene. Anzi. E più restava, più ad andarsene, pensate un po', erano le mie allergie. Improvvisamente la primavera non mi sorprendeva più come un attentato. Avevo addirittura assaggiato i pomodori dell'orto del padre di Giacomo, che dopo la morte di Giuditta si era trasferito in campagna: non mi avevano macchiato le braccia di chiazze. Li avevo addirittura trovati molto buoni. Piante rampicanti, api, crini di cavallo: tanti altri erano stati i nemici, durante quei giorni in campagna. Tutti vinti senza nemmeno il bisogno di affrontarli. – Lo sapevo io, che a un certo punto la tiravi fuori, la forza. – Diceva dicendolo mio padre. – Sei o non sei figlia mia? – Ti sei fatta pure carina, finalmente. – Diceva dicendolo mia madre. Che Giacomo fosse figlio di Giuditta, lì per lì non era stato facile per lei da accettare: ma se accettava di averci sempre e da sempre quella per casa, sarebbe stato sciocco creare dei problemi proprio adesso. Adesso che sua figlia si era fatta pure carina, finalmente. – Sei bellissima. – Mi diceva Giacomo in continuazione, mentre mi spogliava e mi carezzava, piano. Solo una volta ho rischiato di riprendere a tossire e vomitare: quando si è spinto un po' più in là e dalle carezze è passato a strusciarsi addosso a me, nudo pure lui. Ma ancora prima che potessi sentirmi poco bene, mi ha guardata negli occhi, ha capito meglio di me che cosa stava succedendo e mi ha sussurrato in un orecchio: – Io non ho nessuna fretta. L'hai capito o no che voglio passare la vita intera, con te? Quella sera, a letto, Edoardo non mi ha rivolto la parola. Continuavo a cercare, nel buio, la sua intelligenza, mi allungavo per raggiungere i suoi versi, il suo tono scherzoso. Ma niente. Non mi veniva incontro, non mi rispondeva. Anche mio fratello si era fatto freddo. Distante. Lui, sempre così pronto ad attirare su di sé l'attenzione, se ne stava quasi sempre con nonno Marcello, chissà dove: uscivano presto, la mattina, e tornavano quando io dormivo già. Giacomo era diventato di casa, si fermava spesso a cena con noi e allora Giuditta, imbarazzata, preferiva andare a farsi un giro e chiedeva evidentemente alla Lella e alla tabaccaia di seguirla. Perché non si facevano più vedere nemmeno loro. Non ci capivo più niente, niente. Giorno dopo giorno la testa mi girava a vuoto. Hai voglia a fare finta, con Giacomo, che tutto andasse bene. Mi sapeva frugare dentro, lui. Mi stringeva a sé, mi accarezzava le spalle, mi baciava le braccia e mi prometteva: – Di me ti puoi fidare. Che cos'è che non va? Non devi avere paura di niente. Non quando ci sono io. E ci sarò sempre. Capito. Sempre? Anche quella sera, a cena da lui, in mansarda. Il suo compagno di specializzazione non c'era. Aveva apparecchiato la tavola con le candele, una tovaglia nuova. Mi ha servito la pasta con il sugo dell'orto di suo padre, ha grattuggiato il parmigiano: ormai mangiavo tutto. E proprio così ha ripetuto. – Ci sarò sempre. Ha tirato fuori dalla tasca un anello, si è inginocchiato di fronte a me. Allora sì. Prima che mi chiedesse quello che stava per chiedermi l'ho ammazzato. Ho preso il coltello e gliel'ho ficcato nel cuore. Perché? Perché mi girava la testa a vuoto, ve lo ripeto. E perché nel momento esatto in cui Giacomo si è messo in ginocchio, mio fratello è esploso a piangere, nell'altra stanza o chissà dove, disperato. E Edoardo mi ha sussurrato in un orecchio: – Signorina Allergia – Ma non con il suo tono scherzoso. Con un tono triste. Tristissimo. Come a dire allora mi stai lasciando per davvero, Signorina Allergia. Così ho dovuto scegliere. O Giacomo o Edoardo. O Giacomo o quello che non si vede, quello che non si deve, quello che non si può, che non si tocca, non ci tocca, quello che non significa niente, quello che determina tutto, quello per cui vale la pena esistere: quello che non esiste più, che non è mai esistito, non esisterà. Ho dovuto scegliere. Voi che cosa avreste fatto, scusate? Vi sareste appellati a una di quelle scemenze con cui ogni tanto ho provato a confondere me stessa, e magari vi ho incidentalmente confuso? Io no. Io non ho avuto dubbi. Ho fatto quello che dovevo fare. E ho ricominciato, finalmente, a tossire. Chiara Gamberale Fonte: C. Gamberale, Signorina Allergia, in W. Siti, Granta Italia, vol. VI, Rizzoli, Milano 2015.
- Memoriale di guerra
Nel luglio del 1942 prestavo servizio con la Divisione Nuova Zelanda nella parte ovest del deserto. Allora cercavamo di contenere l'avanzata di Rommel in Egitto. Il 17 luglio 1942 sono stato preso dalle truppe della 21ª Panzer Division e della 190ª Divisione di Fanteria Leggera. Fui portato alla prigione del campo di El Daba e successivamente alla prigione del campo di Mersa Matruh dove sono stato consegnato al Comando italiano. Fui portato da Matruh a Tobruk e da Tobruk a Benghazi. A Benghazi sono stato imbarcato per l'Italia attraverso la Grecia ed il Canale di Corinto. Attraccammo a Taranto e da lì fummo portati ad Altamura vicino Bari. Dopo aver passato lì diversi mesi tra i disagi fummo mandati in treno a Turturano dove siamo rimasti fino a Natale. Da lì fummo mandati al campo di lavoro PG 78/1 di Acquafredda. Il campo da cui dipendevamo era il 78 di Sulmona. Al momento dell'Armistizio le guardie del nostro campo erano molto in ansia e incerte sul da farsi. Otto di noi approfittarono della loro incertezza e decisero di cercare di arrivare al campo di Sulmona. Per arrivare a Sulmona dovevamo scendere nella vallata al di sotto del nostro campo ed attraversare una catena di alture. Sulmona era dall'altra parte. Lasciai i compagni nella vallata e attraversai le alture. Quando raggiunsi una posizione vicina alla recinzione del campo potei vedere che i Tedeschi avevano preso il controllo del campo. Tornai indietro dai miei compagni che aspettavano. Decidemmo di dirigerci, attraverso le alture, verso Foggia dove si trovavano le nostre truppe e dopo esserci messi d'accordo sul da farsi ci muovemmo. Ci sembrava sempre di attraversare valli e scalare alture ed in una sola tappa attraversammo una parte della catena degli Appennini. Nel fare ciò eravamo ben al di sopra dell'altitudine alla quale abitualmente nevica e lì su incontrammo dei guardiani di greggi di capre. Dovunque andassimo incontravamo sempre italiani in posti inaspettati ed era impossibile andare lontano senza incontrare qualcuno. Una mattina mentre eravamo sul pendio di un'altura fummo avvicinati da due civili che parlavano un ottimo inglese. Chiacchierarono con noi per un po' ed erano d'accordo sul nostro proposito di dirigerci verso Foggia tenendoci sulle alture. Al di là della valle potevamo vedere un'altura sulla cui sommità c'era una grande croce. Attorno all'altura c'era una strada che portava ad un paese in cima. Giù nella valle c'era un ruscello. Proseguimmo sulle rive del ruscello nella valle per tenerci lontano dalla strada nel caso in cui i Tedeschi la usassero. Vicino la strada vedemmo un cavallo ed un carretto con un civile Italiano a cui chiesi nel mio italiano davvero stentato se ci fossero i Tedeschi nel paese. Avendomi detto di no gli chiesi istruzioni per raggiungere Foggia ed anche cibo per il nostro gruppo. All'inizio, credo, ci prese per tedeschi ma dopo avergli parlato un po' volle sapere se ero inglese. Dopo avergli detto che eravamo tutti neozelandesi ci portò a casa sua sotto il paese e ci diede del cibo. Questa era la casa dei fratelli Fiadino. C'erano tre fratelli tutti sposati e con figli. Non ricordo i loro nomi di battesimo. Più tardi uno dei fratelli ci portò su a Capracotta nella casa della signora Pia Jaselli. La signora Jaselli, dopo aver ascoltato i nostri progetti suggerì di rimanere in zona e di aspettare le nostre truppe che, allora, stavano risalendo rapidamente l'Italia. Dopo aver camminato su e giù per le montagne dell'Italia per tutta la settimana pensammo davvero che questa fosse una buona idea. Nel pomeriggio tornammo presso la casa dei fratelli Fiadino e ci passammo la notte. Il giorno dopo ci portarono nella boscaglia dietro la loro casa. Dopo circa un'ora di cammino arrivammo ad una chiesa costruita sul fianco di un precipizio. Mi sembra che fosse chiamata la Chiesa di San Luca. Dietro la chiesa, sempre ricavati nella roccia a strapiombo c'erano degli ambienti molto primitivi. Appena sotto era stata costruita un'altra chiesa in blocchi di cemento e nella vallata al di sotto si poteva vedere un paese. Credo fosse il paese di Sant'Angelo. Eravamo di notte in quei piccoli ambienti dietro la chiesa mentre di giorno generalmente esploravamo la boscaglia per orientarci. Facevamo visita a Sant'Angelo per tenere sotto controllo gli spostamenti dei tedeschi in quella zona e due volte a settimana andavamo dalla signora Jaselli per le notizie e le provviste. Lì ho conosciuto alcuni degli amici della signora Jaselli, uno dei quali era un insegnante. Due del nostro gruppo decisero di stare nella casa dei fratelli Fiadino per lavorare nella loro masseria. Alcuni giorni più tardi uno dei fratelli Fiadino venne fin sulla Chiesa di San Luca per dirci che eravamo stati denunciati ai Tedeschi da qualcuno a Sant'Angelo. Mettemmo insieme le poche cose che avevamo e andammo con lui fino ad un casotto in pietra usato dai pastori sul pendio della montagna sopra la casa dei Fiadino. Durante il giorno andammo nella boscaglia e all'imbrunire le donne dei Fiadino ci portarono un pasto caldo che è stata la cosa migliore che avessi mai assaggiato. Non so esprimere la nostra gratitudine per il cibo che queste donne ci davano. Dopo alcuni giorni nella nostra nuova posizione tornai alla chiesa per dare un'occhiata. Lì dove eravamo stati trovammo giornali tedeschi che dimostravano che una pattuglia tedesca era stata mandata per trovarci. Da questo momento in poi vedemmo aumentare l'attività dei Tedeschi che cominciavano ad essere in numero sempre maggiore nella zona. Fortunatamente potevamo ancora andare dalla signora Jaselli che ci teneva informati sull'avanzata delle forze alleate e che ci dava anche da mangiare. Si facevano saltare in aria i cunicoli e veniva posizionata della contraerea leggera. A questo punto si decise che sarebbe stato più sicuro per tutti se i due compagni che lavoravano presso la masseria dei Fiadino si fossero riuniti a noi. Ciò fu fatto e da quel momento fino a quando fummo ricatturati le donne dei Fiadino ci diedero un pasto caldo ogni sera. Una sera all'imbrunire andai a Capracotta e come al solito feci visita alla signora Jaselli sotto la cui casa c'era un garage. Una porta conduceva dal garage fino alla casa e questa era la strada che normalmente facevamo quando andavamo là. Nell'arrivare, trovai la signora Jaselli che aspettava sulla porta del garage. Mi disse che i Tedeschi avevano occupato il paese e che aveva gli ufficiali tedeschi alloggiati in casa sua. Questa fu l'ultima volta che andammo liberamente a casa sua. Comunque ci mandò ancora cibo e sigari che le erano dati dai Tedeschi. Tornando al casotto dei pastori avvertii il resto del gruppo e dissi loro di essere molto attenti a non farsi vedere di giorno dai Tedeschi o dai simpatizzanti fascisti. Durante il giorno andavamo su nella boscaglia ed avevamo un occhio attento alla strada lungo la quale ora si muovevano i Tedeschi. Le nostre truppe si avvicinavano sempre di più ed ora potevamo sentire i bombardamenti. Un pomeriggio mentre eravamo nella boscaglia uno dei fratelli Fiadino portò alcuni soldati alleati, un aviatore americano ed anche una guida siciliana. Questa guida era uno zoppo ed aveva il "piede equino". Ci fu detto che questa guida stava conducendo l'altro gruppo dalle truppe alleate attraverso le linee tedesche. A questo punto non avevamo alcuna ragione di sospettare e così ci accordammo che dopo che avesse portato questo gruppo in salvo sarebbe tornato indietro per noi e ci avrebbe portati oltre le linee tedesche per il compenso di 10 lire ciascuno. Stettero con noi nel casotto quella notte e partirono verso le linee tedesche, ad Agnone, il giorno dopo. Tutto ciò che potevamo fare ora era aspettare. Come al solito, due o tre notti dopo, scendemmo per il nostro pasto caldo e poi tornammo nel nostro casotto per la notte. Ci addormentammo verso le 8 perché non potendo avere una luce o il fuoco ci coricammo appena si fece scuro. Fummo svegliati da alcuni colpi che furono sparati nel casotto e non potemmo fare altro che uscire dalla porta perché il casotto aveva solo una porta e nessuna finestra. All'esterno c'era una pattuglia di Tedeschi e con loro uno dei fratelli Fiadino. Più tardi scoprimmo che il siciliano zoppo aveva portato la pattuglia tedesca alla casa dei Fiadino e i Tedeschi avevano costretto uno dei fratelli a portarli al nostro nascondiglio. Sembra che questo zoppo fosse pagato dai Tedeschi per raccogliere gruppi di prigionieri di guerra. Si spacciava per una guida e portava i gruppi di prigionieri dai Tedeschi. I tre fratelli Fiadino furono trattati brutalmente dai Tedeschi e portati con noi a Capracotta al Comando tedesco che era nella casa della signora Jaselli. Fummo tenuti per il resto della notte in questa casa dai Tedeschi. Il mattino seguente fummo caricati su un camion tedesco e scaricati poi sul ciglio di una strada. Il più anziano dei Fiadino fu un po' lento nello scendere dal camion e così un tedesco gli diede una spinta mandandolo oltre il bordo della strada su una scarpata. L'italiano riuscì a mantenersi in equilibrio e continuò a correre sebbene i tedeschi gli spararono con qualsiasi cosa avessero, ma lui riuscì a scappare e dopo avemmo notizia che era riuscito a mettersi in salvo. Gli altri fratelli Fiadino furono separati da noi che fummo rinchiusi in un altro edificio dove trovammo l'altro gruppo che ci aveva lasciati accompagnati dallo zoppo. Da qui fummo mandati nelle prigioni di guerra di Chieti e L'Aquila. Poi fummo messi su un treno diretto in Germania attraverso il Brennero al campo di prigionia Moosburg Stalag VII-A l'otto novembre 1943. Per caso, successivamente, sapemmo che i due fratelli Fiadino rimasti prigionieri dei Tedeschi furono processati e fucilati. Francis Parker (trad. di Fernando Di Nucci) Fonte: http://www.capracotta.com/, novembre 1999.
- Quelle Madonne sotto il baldacchino
In alcune fotografie d'epoca è possibile vedere la nostra Madonna di Loreto che procede sotto il baldacchino. Ma siamo sicuri che le immagini dei santi si possano portare in processione sotto il baldacchino? La risposta ufficiale è no: non è permesso. Con un decreto del 22 agosto 1744 ed uno dell'11 aprile 1840, la Congregazione dei Riti decise che si potevano portare in processione sotto il baldacchino soltanto il Venerabile, il legno della Croce e gli altri strumenti della passione di Cristo. Non era dunque permesso fare il medesimo onore alle reliquie dei santi, alle loro immagini, e neppure a quella della Vergine, perché, qualunque fosse stata la Sua dignità e grandezza, la Madonna era pur sempre una creatura in carne e ossa, e perciò non la si doveva onorare al pari di Gesù Cristo e dei sacri oggetti che direttamente ad Egli si riferivano. La Sacra Congregazione dei Riti è un istituto fondato nel 1588 da papa Sisto V col nome di Congregatio pro Sacris Ritibus et Cæremoniis. Questa si è a lungo occupata della canonizzazione e del culto dei santi, nonché dell'organizzazione delle cerimonie pontificie; tuttavia in molti ambiti ha ceduto le proprie funzioni ad altri istituti, ed oggi appare divisa in due congregazioni autonome, una per le cause dei santi e l'altra per il culto divino. Il decreto dell'11 aprile 1840 che ho menzionato riguardava proprio Capracotta e la sua Congrega della Madonna del Monte Carmelo, dacché questa aveva chiesto alla Sacra Congregazione dei Riti la possibilità di far sfilare la Beata Vergine Maria del Carmine sotto l'agognato baldacchino. Il sinodo ordinario, riunitosi in Vaticano, rispose che, nonostante la statua si riferisse alla Madonna, per cui andava sì osservato il decreto generale che proibiva l'apposizione di immagini sacre al di sotto del baldacchino tuttavia lo permetteva per «speciali gratia»: Quum hodiernus Prior Congregationis Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo loci Capracotta Dioecesis Triventin. Sacrorum Rituum Congregationem instanter rogarit, ut, non obstante Generali Decreto prohibente deferri sub Baldachino Sanctorum Imagines, id permitteret de speciali gratia eidem Congregationi quoad Simulacrum Beatæ Mariæ eodem sub titulo; Sacra eadem Congregatio in Ordinario Coetu ad Vaticanum subsignata die coadunata, rescribendum censuit: Servetur Generale Decretum. Fatto sta che nei secoli la norma canonica - tanto a Capracotta quanto nell'intero Meridione - non è stata seguita alla lettera e le immagini sacre coperte e svelate nel giorno di festa, o portate direttamente in processione sotto il baldacchino, sono molto più di un'eccezione che conferma la regola. La religiosità del popolo è spesso più pervicace di quella codificata dal clero. Francesco Mendozzi Bibliografia di riferimento: A. Gardellini, Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum, libro VII, Bourlié, Roma 1826; A. Guillois, Spiegazione storica, dogmatica, morale, liturgica e canonica del Catechismo, vol. II, Guasti, Prato 1865; F. Mendozzi, Guida alla letteratura capracottese, vol. I, Youcanprint, Tricase 2016.